Gli Stati Uniti di fronte a se stessi
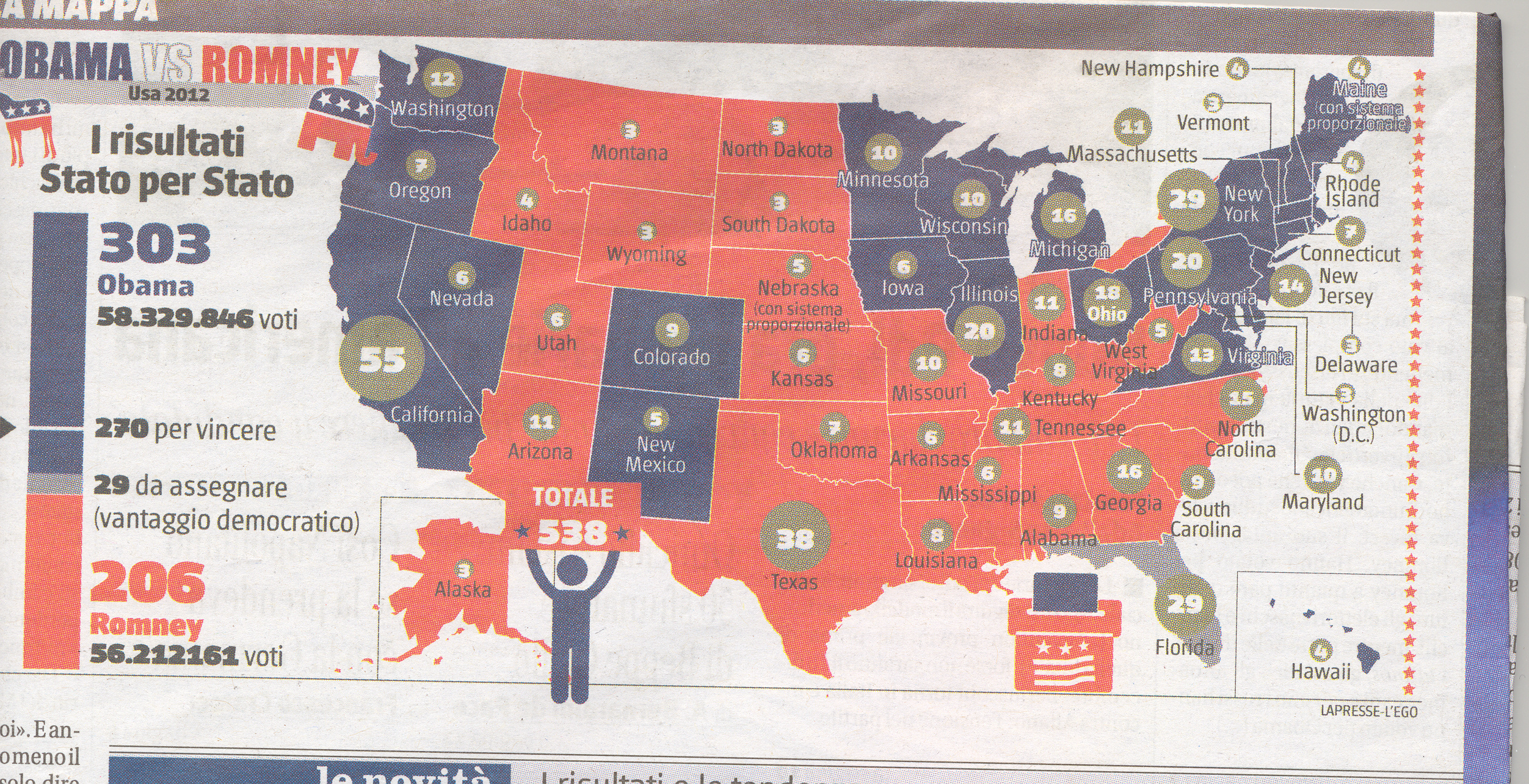
Gli Stati Uniti non sono più la potenza di un tempo ma sono ancora la prima superpotenza dell’orbe terracqueo. Washington, rispetto al recente passato, sconta una concorrenza più accesa su alcuni scenari regionali ma è ancora essa a tirare i fili dell’ordine globale, scaturito dagli esiti del II conflitto mondiale e dalla fine della Guerra Fredda. Questa situazione di arretramento ha convinto qualcuno a parlare di declino americano ma non esattamente di ciò si tratta. Gli Usa hanno ancora un controllo stabile del loro campo di pertinenza, quello detto Occidentale, mentre devono affrontare sfide crescenti su diversi teatri, quelli orientali in primis, dove Russia e Cina stanno recuperando preziose posizioni, ridisegnando o allargando le loro sfere d’influenza. Questa situazione più aperta segna, certamente, la fine dell’assoluto unipolarismo americano e schiude le porte a forme di multilateralismo e multipolarismo, le quali hanno ancora molta strada da percorrere per giungere a rappresentare una tendenza storica irreversibile, quella che dovrebbe ulteriormente sfociare nel pieno policentrismo, una fase in cui gli attori geopolitici giocano quasi alla pari le loro chance di successo.
Il processo di cui parliamo è avviato ma incede a scatti, con interruzioni e riprese, ripiegamenti e piccole avanzate, fenomeni causati proprio dagli ostacoli che gli statunitensi, ancora in possesso di un vantaggio strategico sui competitori, frappongono sul percorso che porta al riequilibrio dei rapporti di forza internazionali, quale punto di partenza di grandi sfide successive per la predominanza tra player geopolitici.
Gran parte del disordine che osserviamo in alcune aree periferiche o semi-periferiche del pianeta, come il Nord-Africa, il Medio-Oriente e, adesso, persino ai margini esterni dell’UE (Ucraina), è provocato dall’azione americana, che, in mancanza di piani precisi e di una visione organica del proprio futuro, semina il caos per impedire che ad avvantaggiarsi delle sue “debolezze” siano altri, proprio nel mentre essa cerca delle soluzioni adatte a salvaguardare le proprie esclusive prerogative. Nonostante tutta la sua spregiudicatezza militare e culturale, Washington è ormai una potenza oggettivamente conservatrice, perché punta a preservare lo statu quo della sua preminenza in un’epoca che difficilmente può reggerlo così com’è. Le vere potenze rivoluzionarie – anche se paradossalmente richiamantesi a tradizioni del passato e a costumi meno permissivi – sono la Russia e la Cina, le quali, invece, stanno agendo per un allargamento dei loro orizzonti di proiezione politica ed economica, in un contesto che non le premia abbastanza e non corrisponde alle loro potenzialità. Siccome la miglior difesa è sempre l’attacco, anche se disordinato, gli Stati Uniti vanno seminando il panico ovunque per riorganizzarsi, togliere punti di riferimento ai loro antagonisti e trascinarli in conflitti, culturali o militari, di varia entità che mirano a disperdere le loro energie. Tuttavia, gli Usa, imboccando la via strategica dell’interventismo caotico stanno rischiando di incorrere in un corto circuito ideologico che potrebbe presto rivelarsi un boomerang. Washington ha giustificato il suo ruolo di poliziotto globale servendosi di una retorica dei valori universali (quelli della democrazia, della libertà e dei diritti umani ) i quali non riescono più a celare i suoi obiettivi reali. La crescente materialità (e brutalità) di quest’ultimi esonda dai contorni dei principi adottati per legittimarli e non li cela abbastanza agli occhi della pubblica opinione, tanto da divenire ostativi per il raggiungimento degli scopi prefissati. Qualche mese fa, Thomas L. Friedman, columnist del NYT ed autore di saggi di geopolitica, prendendo atto di questa situazione, giunse ad affermare che per gli Usa era arrivato il momento di smettere i panni del gendarme buono e di vestire quelli dell’agente cattivo che opera ad esclusiva tutela dei propri interessi diretti, senza troppi infingimenti e giri di parole. Tale motivazione è sufficiente per intraprendere qualsiasi azione indirizzata alla preservazione dell’ordine mondiale che ha al suo apice gli Usa. Secondo lo studioso, il periodo della carota si è irrimediabilmente concluso, ora è il momento del bastone. Basta con i discorsi demagogici e le perdite di tempo per perorare, soprattutto presso gli alleati, la causa della democrazia e dei diritti umani come mezzo di persuasione “gentile” e di coinvolgimento collettivo. Occorre derubricare il soft power e ricorrere alla mano pesante per ottenere la vittoria e non perdere posizioni. Washington dovrebbe avere il coraggio d’intervenire nelle contese internazionali facendo appello all’unica ragione che davvero le interessa: la sua sicurezza nazionale che ha come limite i margini della sua capacità di proiezione. Essa, infatti, viene prima delle grandi narrazioni di copertura, delle forme di esortazione blanda, quelle col guanto di velluto, di cui l’America si è servita in precedenza per “legalizzare” le sue ingerenze all’estero. Dunque, fine dell’ipocrisia e bando alle ciance, è la ragione del più forte che autorizza qualsiasi intromissione negli affari altrui. L’America, secondo Friedman, deve mostrarsi per quello che è, il perno del pianeta e il vertice della sua gerarchia e come tale deve comportarsi, picchiando sulle teste di chi si oppone ed alzando il prezzo della resistenza dei recalcitranti. Se c’è qualcuno che vuole sfidare la preminenza degli Usa ne pagherà le conseguenze senza indulgenza. Questo ragionamento nudo e crudo, ma più veritiero, smitizza il sogno americano e ne porta alla luce il substrato aggressivo. L’America perde la sua innocenza di facciata davanti ai popoli della terra, dopo aver edificato la sua immagine su una moralità universale, esportabile in ogni territorio abitato e con qualsiasi mezzo. La democrazia statunitense, fondata sul mito dell’espansione delle libertà, smobilitando l’impalcatura di suggestioni dietro la quale si è sin qui arroccata, apparirebbe, infine, quale essa è sempre stata concretamente, una forma di espansionismo senz’altra specificazione. La nazione che chiamava “destino manifesto” il suo imperialismo, stigmatizzando quello altrui, si ritroverebbe così messa di fronte ad uno specchio. L’America che vede tiranni dappertutto (soprattutto laddove viene ostacolata nelle sue intenzioni) potrà finalmente guardarsi dritta nelle pupille e scoprire che il male è, specialmente, negli occhi di chi lo vede. Col diavolo che ci mette lo zampino ci aspettiamo anche che Dio si dichiari neutrale lasciando agli uomini il compito di sbrigarsela da soli.
