MARX NON ERA IDEALISTA, MARX NON ERA UN FILOSOFO.




Questo testo è stato per l’essenziale scritto nel dicembre 1997. E’ stato poi presentato l’anno successivo con qualche correzione (in specie di nota) all’importante Convegno Internazionale di Parigi dedicato al 150° anniversario del Manifesto marxiano del 1848. Il caro amico […]
Continua a leggere
http://www.dellarepubblica.it/congressi-pci/viii-congresso-roma-palazzo-dell-eur-8-14-dicembre-1956 leggere soprattutto relazione Togliatti nell’Unità del 9 dicembre e tutte le chiacchiere sulla “via italiana al socialismo”; con riforme di struttura, alleanza con i ceti medi, ecc. Non è l’inizio della via opportunistica di Togliatti, ma certo un passo […]
Continua a leggereAMAZON LIBRI
Da Marx in poi. Ripensiamo nuovi possibili percorsi
di Gianfranco La Grassa | 1 gen. 2030
Copertina flessibile
20,00 €20,00€
Prenotazione al prezzo minimo garantito
Spedizione GRATUITA sul tuo primo ordine spedito da Amazon
Questo articolo non è ancora disponibile.
Da Marx in poi: Ripensiamo nuovi possibili percorsi
di Gianfranco La Grassa
Formato Kindle
13,99 €13,99€
Disponibile ora
IBS LIBRI
https://www.ibs.it/da-marx-in-poi-ebook-gianfranco-la-grassa/e/9788857569888
come annunciato, il 28 maggio è uscito “Da Marx in poi”, Mimesis. Per il momento è disponibile la versione elettronica. Tuttavia, ho già ricevuto le copie cartacee ordinate alla casa editrice. Dunque, è comunque già stampato. Spero sia presto disponibile anche quella versione. Capisco che chi nemmeno compra “La follia è vita”, non si farà vivo per questo che richiede certe competenze. Tuttavia, mi auguro che su oltre 4700 cosiddetti amici ci sia una discreta quota in grado di leggere un libro come questo. Quindi, compratelo altrimenti vi mando tutte le maledizioni possibili.
DA MARX IN POI, IL NUOVO LIBRO DI LA GRASSA – INTRODUZIONE E VIDEO DI PRESENTAZIONE
COMPRATE, COMPRATE E LEGGETE, LEGGETE
Continua a leggere
Introduzione di Gianni Petrosillo
Ma sulle soglie della scienza, come sulle soglie dell’Inferno, va posto il monito severo: Qui si convien lasciare ogni sospetto. Ogni viltà convien che qui sia morta. Karl Marx.
1. In questo saggio su Marx, Gianfranco La Grassa tenta di evidenziare (ed interpretare), con ancora più precisione, quelli che sono i capisaldi scientifici che sorreggono l’apparato teorico del pensatore tedesco. Si badi bene, non si tratta di operazione nostalgica onde vivificare previsioni concettuali ormai consegnate, quasi senza scampo, ai non avveramenti della Storia. Semmai, intento di La Grassa è quello di fissare l’importanza di concetti acquisiti, sgombrando contemporaneamente il campo dai detriti di esegesi del marxismo (eretiche o ortodosse) non adeguate, oltre che ormai consumate da eventi e risvolti contrari alle intuizioni del “Fondatore”, al fine di descrivere i nuovi scenari che incalzano le nostre società, in virtù di mutamenti evidenti, intervenuti in oltre 150 anni dalla stesura de Das Kapital. Tuttavia, per ri-generare un pensiero, o servirsene come solida base per un diverso concepimento (nulla nasce dal nulla, tanto meno le idee), è necessario afferrare esattamente quello che si sta lasciando definitivamente alle spalle e quello che, invece, si porterà con sé, per non duplicare fatiche o disperdere energie intorno a tematiche effettivamente sceverate, assimilate o irrimediabilmente decadute. Per intenderci, non ha più molto senso arrovellarsi sulla teoria del valore, soprattutto nei suoi elementi matematici (la trasformazione dei valori nei prezzi di produzione), bisogna piuttosto inferirla nella sua forza descrittiva generale (nelle sue conclusioni) poiché essa, molto meglio di dottrine concorrenti (o sola tra esse), svela la natura e la funzione del plusprodotto (nella forma astratta del plusvalore) e, dunque, anche del profitto, in un determinato tipo di sistema sociale quale quello capitalistico. La teoria del valore lavoro ha, infatti, una funzione di “disvelamento della realtà capitalistica, della sua strutturazione e dinamica, delle lotte che in essa si sono svolte e si svolgono, dei blocchi sociali che si sono affrontati e si affrontano… del perché, degli obiettivi e risultati di questo affrontamento”. La teoria del valore ci interessa, in sostanza, per le sue implicazioni “sociali” (presa del potere o egemonia nella società), interesse che non collima con quello dei capitalisti o dei loro ideologi ai quali basta superficialmente districarsi tra prezzi, costi e ricavi monetari, fenomeni evidenti di un mondo in cui essi si trovano ben posizionati perché appartenenti alle classi dominanti. Ma sono dominanti in quanto storicamente (e socialmente) si è verificata quella che La Grassa definisce una duplice scissione: a) tra proprietà dei mezzi di produzione e forza lavoro che acquisisce la forma di merce in quanto unica “proprietà” di individui liberi ma spossessati, e che debbono pur vivere comprando valori d’uso come merci; b) quella tra prestazione d’uso di tale forza lavoro e gli uomini (nella loro complessa personalità) che la possiedono e debbono venderla quale unico mezzo per vivere… Il fulcro di un simile conflitto (detto “di classe”), comunque uno dei suoi problemi decisivi, è l’appropriazione del plusprodotto che avviene, in forme di società diverse, secondo modalità (sociali) differenti, secondo una dinamica di riproduzione dei decisivi rapporti di ogni data società – quei rapporti definiti dal concetto di modo sociale di produzione – che è specifica della società in questione. Dunque, la teoria del valore assume importanza cruciale laddove fornisce una spiegazione della “struttura e dinamica dei rapporti sociali di produzione capitalistici”. Questo è lo spirito con cui Marx si cimenta nella sua elaborazione, tutt’altro che meramente economicistica ovvero schiacciata sul tentativo ossessivo di arrivare all’esatta misurazione del plusvalore “estorto” alla classe lavoratrice, alla esatta “trasformazione” (dei valori in prezzi di produzione), alla inverificabile caduta tendenziale del saggio di profitto ecc. ecc. Marx riconosce alla sfera economica nel capitalismo una certa supremazia (legata all’efficacia dei sistemi di estrazione del pluslavoro/plusvalore), ma va appuntato che gli interessano in primo luogo i rapporti sociali (il capitale non è cosa ma rapporto sociale) di detta sfera. Le operazioni cervellotiche dei suoi epigoni, alcuni dei quali, anche nostri contemporanei, avrebbero risolto il dilemma dei dilemmi, quello della esatta coincidenza tra valori e prezzi di produzione, avrebbero fatto sobbalzare Marx dal suo scrittoio. Fu lui stesso ad affermare che tale riscontro sarebbe stato impossibile in circostanze reali e non puramente teoriche. Se vogliamo dirla tutta, tra realtà e legisimilità (astratta) c’è uno scarto e l’autore del Capitale lo ribadisce a più riprese, sia quando parla della “trasformazione” ma anche quando affronta le leggi interne della produzione capitalistica mediante l’azione di domanda e offerta. In questo passaggio viene in evidenza la modalità scientifica marxiana allorché precisa: Spiegare le vere leggi interne della produzione capitalistica mediante l’azione e reazione di domanda ed offerta è chiaramente impossibile (a prescindere da un’analisi più profonda, che qui tralasciamo, di queste due forze motrici sociali), perché tali leggi appaiono realizzate nella loro purezza solo allorché domanda ed offerta cessano di operare, cioè coincidono. In realtà, domanda ed offerta non coincidono mai o, se ciò avviene, è solo per caso; dunque, dal punto di vista scientifico, la loro coincidenza va posta = 0, deve ritenersi non accaduta. Eppure, nell’economia politica si suppone che esse coincidano. Perché? Da un lato, per poter studiare i fenomeni nella loro forma normale, corrispondente al loro concetto, dunque fuori dell’apparenza generata dal movimento di domanda ed offerta; dall’altro, per individuare la tendenza effettiva del loro movimento e, in qualche modo, fissarla (sottolineature mie). Le diseguaglianze sono infatti di natura antagonistica e, dato che seguono costantemente l’una all’altra, finiscono per compensarsi appunto in virtù delle loro opposte direzioni, del loro antagonismo. Se perciò domanda e offerta non coincidono in nessun caso singolo dato, le loro diseguaglianze si susseguono — e il risultato della deviazione in un senso è di provocarne un’altra in senso inverso — in modo che, considerando l’insieme di un periodo più o meno lungo, offerta e domanda costantemente si pareggiano, ma solo come media del movimento trascorso e solo come moto costante del loro antagonismo. Così i prezzi di mercato divergenti dai valori di mercato si livellano, ove se ne consideri il numero medio, sui valori di mercato, perché gli scarti in più e in meno da questi ultimi si elidono a vicenda. E, per il capitale, questo numero medio ha un’importanza non puramente teorica ma pratica, in quanto il suo investimento è calcolato in base alle oscillazioni e compensazioni su un arco di tempo più o meno preciso. Dunque, da un lato il rapporto fra domanda ed offerta spiega soltanto le deviazioni dei prezzi di mercato dai valori di mercato, dall’altro spiega la tendenza ad annullare tali deviazioni, cioè gli effetti del rapporto fra domanda ed offerta (Karl Marx, Il Capitale, sez. IV, Cap.X, Utet). Marx è un Galileo della scienza sociale, sostiene La Grassa, perché intuisce che “per esporre le leggi dell’economia politica nella loro purezza, si astrae dalle frizioni, allo stesso modo che, nella meccanica pura, si astrae da frizioni determinate che, in ogni caso singolo della sua applicazione, devono essere superate”, o anche meglio in questo passaggio: Il fisico osserva i processi naturali nel luogo dove essi si presentano nella forma più pregnante e meno offuscata da influssi perturbatori, oppure, quando è possibile, fa esperimenti in condizioni tali da garantire lo svolgersi del processo allo stato puro. In quest’opera debbo indagare il modo capitalistico di produzione e i rapporti di produzione e di scambio che gli corrispondono. Fino a questo momento, loro sede classica è l’Inghilterra. Per questa ragione è l’Inghilterra principalmente che serve a illustrare lo svolgimento della mia teoria. Ma nel caso che il lettore tedesco si stringesse farisaicamente nelle spalle a proposito delle condizioni degli operai inglesi dell’industria e dell’agricoltura o si acquietasse ottimisticamente al pensiero che in Germania ci manca ancora molto che le cose vadano così male, gli debbo gridare: de te fabula narratur! (Karl Marx, Il Capitale, prefazione alla prima edizione, Utet).
2.Leggere Marx attraverso le lenti lagrassiane schiude continenti analitici inusuali, strade non battute da altri commentatori (per dirla con le parole di una poesia di Robert Frost, citata nel libro), troppo superficiali o a volte, persino, in malafede. La Grassa punta a restituire al marxismo il suo vero ruolo scientifico, depurato delle fantasie utopistiche o filosofiche dei suoi presunti allievi auto-accreditatisi tali, adusi a de-razionalizzare (col ricorso ad afflati morali, umanitari ecc. atti a coprire pesanti deficit analitici) i suoi studi per inseguire chimere ideologiche. Il punto di partenza oggettivo da cui si sviluppa l’indagine storico-economica marxiana è il conflitto per il plusprodotto (caratteristica specifica della sola specie umana, gli animali non hanno questa possibilità) poiché esistono da sempre le classi che lo producono e quelle che se ne appropriano per scopi di egemonia sociale. Queste classi, precisa La Grassa (seguendo Marx), sono formate da “maschere di rapporti sociali”, da “persone che incarnano dati rapporti sociali”, ecc. Anche il pensiero di Marx subisce però una torsione ideologica da parte del marxismo: dalla maschera all’uomo. Esistono uomini proprietari (i “padroni”) e uomini lavoratori (gli operai). Così si è consumato lo sconvolgimento del senso dell’analisi scientifica marxiana, pur se questo processo è con quasi sicurezza quello che ha consentito la saldatura tra nascente movimento operaio e “dottrina” marxista. Senza questa torsione ideologica, Marx sarebbe restato nella storia del pensiero economico e sociale, ma non avrebbe dato il proprio nome ad un movimento che ha segnato un buon secolo di storia. Dopo Cristo (ancora in auge), Marx è probabilmente il personaggio che più a lungo ha orientato un imponente movimento di “masse”. Con la nascita del capitalismo e la divaricazione da esso imposta tra possessori e non possessori dei mezzi di produzione la forma di appropriazione del plusprodotto, da parte delle classi superiori, assume connotazioni uniche (il plusvalore), mai apparse in altre epoche umane. Marx parla di una accumulazione originaria in quanto fase in cui avviene l’espropriazione dei piccoli produttori, da cui consegue la dissoluzione della proprietà privata fondata sul lavoro personale. Ciò significa che da quel “momento” in poi (in senso storico-logico, perché non è avvenuto tutto in un “momento”) chi non aveva mezzi propri per impiegare la propria energia lavorativa avrebbe dovuto rivolgersi a chi li aveva accumulati, ricevendone in cambio un salario in denaro pari alla quota dei beni necessari alla sua sussistenza (storico-sociale). I passaggi riportati nel Capitale sono estremamente chiari ed è utile riconsiderarli qui a supporto del discorso di La Grassa:
Il rapporto capitalistico presuppone la separazione fra i lavoratori e la proprietà delle condizioni di realizzazione del lavoro. La produzione capitalistica, non appena poggi sui suoi piedi, non solo mantiene questa separazione, ma la riproduce su scala sempre crescente. Perciò, il processo che genera il rapporto capitalistico non può essere se non il processo di separazione del lavoratore dalla proprietà delle sue condizioni di lavoro; processo che da un lato trasforma in capitale i mezzi sociali di vita e produzione, dall’altro trasforma i produttori diretti in operai salariati. La cosiddetta accumulazione originaria non è quindi che il processo storico di scissione fra produttore e mezzi di produzione. Essa appare “originaria” perché è la preistoria del capitale e del modo di produzione che gli corrisponde. La struttura economica della società capitalistica è uscita dal grembo della struttura economica della società feudale. La dissoluzione di questa ha messo in libertà gli elementi di quella. Il produttore immediato, o diretto, cioè l’operaio, poteva disporre della sua persona solo dopo di aver cessato d’essere legato alla gleba, e servo di un’altra persona o infeudato ad essa.
Per divenire libero venditore di forza lavoro, che porta la sua merce dovunque essa trovi un mercato, doveva inoltre sottrarsi al dominio delle corporazioni di mestiere, delle loro clausole sugli apprendisti e sui garzoni, dei vincoli delle loro prescrizioni sul lavoro. Così il movimento storico che trasforma i produttori in operai salariati appare da un lato come loro liberazione dalla servitù feudale e dalla coercizione corporativa; e, per i nostri storiografi borghesi, è questo il solo lato che esista. Ma, dall’altro, i neo-emancipati diventano venditori di se stessi solo dopo di essere stati depredati di tutti i loro mezzi di produzione e di tutte le garanzie offerte alla loro esistenza dalle antiche istituzioni feudali. E la storia di questa loro espropriazione è scritta negli annali dell’umanità a caratteri di sangue e di fuoco. I capitalisti industriali, questi nuovi potentati, dovevano da parte loro soppiantare non solo i mastri artigiani delle corporazioni di mestiere, ma anche i signori feudali detentori delle fonti di ricchezza. Da questo lato, la loro ascesa appare come il frutto di una lotta vittoriosa sia contro il potere feudale e i suoi privilegi rivoltanti, sia contro le corporazioni e i limiti ch’esse imponevano al libero sviluppo della produzione e al libero sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. I cavalieri dell’industria, tuttavia, riuscirono a soppiantare i cavalieri della spada solo sfruttando avvenimenti che non erano affatto opera loro. Si fecero strada con mezzi non meno volgari di quelli coi quali il liberto romano si rendeva, in antico, signore del suo patronus. Il punto di partenza dello sviluppo che genera tanto l’operaio salariato, quanto il capitalista, fu la servitù del lavoratore. Il suo prolungamento consistette in un cambiamento di forma di tale servitù, nella trasformazione dello sfruttamento feudale in sfruttamento capitalistico. Per comprenderne il corso, non abbiamo affatto bisogno di risalire molto addietro. Benché i primordi della produzione capitalistica s’incontrino sporadicamente, in alcune città del Mediterraneo, già nei secoli XIV e XV, l’era capitalistica data soltanto dal secolo XVI. Dove essa appare, l’abolizione della servitù della gleba è da tempo un fatto compiuto, e la gloria del Medioevo, l’esistenza di città sovrane, volge, e non da allora, al tramonto. Fanno epoca nella storia dell’accumulazione originaria tutti i rivolgimenti che servono di leva alla classe capitalistica in formazione; ma soprattutto i momenti nei quali grandi masse di uomini vengono, all’improvviso e con la forza, staccate dai loro mezzi di sussistenza e scagliate sul mercato del lavoro come masse di proletari senza terra o dimora. L’espropriazione del produttore agricolo, del contadino, dal possesso del suolo, costituisce la base dell’intero processo. La sua storia prende sfumature diverse nei diversi paesi e percorre le diverse fasi in ordini di successione diversi e in epoche storiche differenti. Solo in Inghilterra, che quindi prendiamo ad esempio, essa possiede forma classica ( Karl Marx, Il Capitale, sez. VII, Cap. XXIV, Utet). Dunque, puntualizza La Grassa, sono stati dei processi storici specifici e originali (quelli innescati dall’accumulazione originaria del capitale) a “liberare” i produttori a) dai vincoli di dipendenza personale e b) dagli strumenti necessari ad attivare lo sforzo lavorativo. Quando il lavoro (la forza-lavoro) diventa merce si generalizza detta forma a livello sociale complessivo e tutti i “manufatti” del lavoro umano, prodotti privatamente, sono direttamente esitati per la compravendita sul mercato che socializza i frutti di tanti lavori privati. I lavoratori, esattamente come i mezzi produttivi, vengono concentrati in unità autonome – prima manifatture poi macchino-fatture, con conseguente transizione del lavoro da una mera sussunzione formale (in cui emergono i sistemi “estorsivi” diretti del plusvalore assoluto, in quanto il Capitale non si è ancora impadronito dell’intero processo lavorativo), a quella reale (in cui primeggiano i metodi “estorsivi” indiretti del plusvalore relativo, in cui il richiamato processo lavorativo diventa forma sociale dominante ed emanazione completa del modo di produzione capitalistico pienamente sviluppato) – in cui si ha la divaricazione verticale tra i pochi proprietari di tali mezzi produttivi e i molti espropriati degli stessi. Contro la forza-lavoro intruppata nell’organizzazione capitalistica si ergono gli strumenti di lavoro proprietà dei capitalisti ai quali appartengono i beni prodotti. La differenza tra il lavoro (valore) prodotto e il valore di mercato della forza-lavoro (pur espresso in moneta quale prezzo, denominato salario) [dà] il profitto (plusvalore) al capitalista-proprietario. In un secondo tempo – ma proprio perché la produzione avviene in centri formalmente indipendenti, sotto la direzione di gruppi di proprietari (capitalisti) tra loro in competizione per accrescere il loro potere e la loro ricchezza mediante l’introduzione di nuove organizzazioni e di nuove tecnologie nei processi di lavoro, con crescente parcellizzazione degli stessi e sostituzione degli strumenti manifatturieri con sistemi meccanici – si verifica la scissione tra saperi produttivi (e capacità direttive) e forza-lavoro semplicemente manuale e/o esecutiva. La spiegazione del pluslavoro / plusvalore fornita da Marx è superiore a quella degli economisti volgari o classici che si fermano all’epidermide dei fenomeni o, meglio, come dice lo stesso tedesco, alla mera grandezza (misura) economica evitando accuratamente di scandagliarne l’origine. A Marx, in sostanza, interessa la struttura ossea del sistema (la base produttiva in cui si sviluppano i rapporti sociali), prima ancora della pelle (“merceologica”) che la ricopre. Questo modo di fare è comune anche agli economisti del nostro tempo i quali schivano, per istinto, il “pericolo” derivante dall’addentrarsi troppo nelle questioni dirimenti. Non è cambiato molto, in questo senso, dai tempi di Marx e non ci è oscura la ragione che spinge gli “esperti” della materia economica ad essere refrattari all’analisi dei rapporti sociali prediligendo essi quella su “indici e numeri”, essendo la loro “appartenenza di classe” ad indirizzarne le modalità di ragionamento:
Ricardo non si preoccupa mai dell’origine del plusvalore. Lo tratta come cosa inerente al modo di produzione capitalistico, che ai suoi occhi è la forma naturale della produzione sociale. Dove parla della produttività del lavoro, cerca in essa non la causa dell’esistenza del plusvalore, ma solo la causa determinante della sua grandezza. Invece, la sua scuola ha proclamato a gran voce che la forza produttiva del lavoro è la causa originaria del profitto (leggi: del plusvalore). Un progresso, comunque, di fronte ai mercantilisti, che da parte loro deducono dallo scambio, dalla vendita dei prodotti al disopra del loro valore, l’eccedenza del prezzo dei prodotti sui loro costi di produzione. Tuttavia, anche la scuola ricardiana aveva solo aggirato, non risolto, il problema. In realtà, questi economisti borghesi avevano il giusto istinto che fosse molto pericoloso scavare troppo a fondo nella questione scottante dell’origine del plusvalore. Ma che dire quando, mezzo secolo dopo Ricardo, il signor John Stuart afferma con grave prosopopea la sua superiorità sui mercantilisti, ripetendo male gli stupidi sotterfugi dei primi volgarizzatori di Ricardo ? Mill dice: “La causa del profitto è, che il lavoro produce più di quanto richieda per il suo mantenimento…”. Fin qui, nulla di diverso dalla vecchia canzone; solo che Mill vuole aggiungervi del suo: “O, per variare la forma del teorema: la ragione per cui il capitale dà un profitto è che gli alimenti, il vestiario, le materie prime e gli strumenti, durano più del tempo necessario a produrli”. Qui, Mill scambia la durata del tempo di lavoro con la durata dei suoi prodotti. Secondo questo modo di vedere, un fornaio, i cui prodotti durano soltanto un giorno, non potrebbe ricavare dai suoi operai salariati lo stesso profitto di un fabbricante di macchine, i cui prodotti durano vent’anni e più. Certo, se i nidi degli uccelli non resistessero più del tempo indispensabile per la loro costruzione, gli uccelli dovrebbero fare a meno dei nidi! Una volta stabilita questa verità fondamentale, Mill stabilisce la propria superiorità sui mercantilisti, scrivendo: “Vediamo dunque che il profitto sorge non dal fatto dello scambio, ma dalla capacità produttiva del lavoro; e il profitto generale di un paese è sempre ciò a cui la capacità produttiva del lavoro lo fa giungere, indipendentemente dalla circostanza che si verifichino o non si verifichino scambi. Se non vi fosse alcuna divisione del lavoro, non vi sarebbero né acquisto né vendita, ma vi sarebbe tuttavia un profitto”. Qui, dunque, lo scambio, la compravendita, le condizioni generali della produzione capitalistica, sono un puro accidente, un “fatto” bruto, e v’è pur sempre profitto senza compravendita della forza lavoro! …Segue uno splendido campione del modo di trattare le diverse forme storiche della produzione sociale, caratteristico di Mill: “Presuppongo sempre”, egli scrive, “lo stato di cose attuale, che, salvo qualche eccezione, predomina dovunque lavoratori e capitalisti costituiscano classi separate, in cui il capitalista fa tutti gli anticipi, inclusa la remunerazione dell’operaio”. Bontà sua, il signor Mill concede che “non è una necessità assoluta che così sia” — neppure nel sistema economico nel quale i lavoratori e i capitalisti si fronteggiano come classi separate. Al contrario: “Il lavoratore potrebbe anche aspettare il pagamento… dell’intero ammontare del suo salario finché il lavoro non sia completamente eseguito, se disponesse dei mezzi necessari per sostentarsi nell’intervallo. Ma in questo caso egli sarebbe in una certa misura un capitalista, che investirebbe capitale nell’azienda e anticiperebbe una parte dei fondi indispensabili per mantenerla in esercizio” Allo stesso titolo, Mill potrebbe sostenere che l’operaio il quale anticipa a se stesso non solo i mezzi di sussistenza, ma i mezzi di lavoro, in realtà è il suo proprio salariato. O che il contadino americano è il suo proprio schiavo, che esegue una corvée per se stesso invece che per un padrone. Dopo di aver spiegato chiaro e tondo che la produzione capitalistica, quand’anche non esistesse, esisterebbe pur sempre, Mill è ora tanto conseguente da dimostrarci che non esiste neppure quando esiste: “E anche nel primo caso” (in cui il capitalista anticipa al salariato tutti i suoi mezzi di sussistenza), “l’operaio può essere considerato in quella luce” (cioè come capitalista), “in quanto, cedendo il suo lavoro al disotto del prezzo di mercato (!), si può ritenere che anticipi la differenza (?) al padrone…”. Nella realtà effettiva, l’operaio anticipa gratuitamente al capitalista il proprio lavoro durante una settimana ecc., per riceverne alla fine della settimana o così via il prezzo di mercato; questo, secondo Mill, farebbe di lui un capitalista! Nel grigiore uniforme della pianura, anche mucchi di terra sembrano colline; si misuri il grigiore dell’odierna borghesia dal calibro dei suoi “grandi cervelli” (Karl Marx, Il Capitale, sez. V, Cap. XIV, Utet). Quei cervelli sono persino peggiorati nel corso dei decenni! Magari avessimo a che fare con dei Ricardo, invece oggi ci toccano menti così prive di fantasia da far cascare le braccia. Ovviamente, secondo La Grassa, ciò non significa che l’economica “ufficiale”, con le sue varie teorie, non faccia scienza. Ad esempio, la teoria marginalistica basata su scelte e preferenze razionali degli individuali lo è in tutti i sensi. Solo che quest’ultima si ferma ad un livello di “attenzione”, a nostro parere, meno profondo di altre concezioni, tipo il marxismo, che sondano l’origine delle problematiche e non esclusivamente il loro manifestarsi in particolari settori o ambiti umani da estendersi, in seconda battuta, all’intero universo sociale come se quest’ultimo fosse prodotto e non causa dell’agire dei singoli. C’è da aggiungere che, nella presente fase di crisi sistemica, molti economisti o presunti dottori della dismal science, anziché studiare con rigore le trasformazioni in corso, preferiscono indossare l’abito sacerdotale dei giustificatori ad oltranza dell’esistente, per puro arrivismo cattedratico o mediatico. A causa di questa loro attitudine che falsa la realtà risultano ormai incapaci di qualsivoglia previsione e finiscono per brancolare nel buio. È così che il liberismo ha smesso di essere una scuola con una tradizione di nomi altisonanti ed è divenuto una fucina di servitori dello statu quo in decadenza. “L’odierno liberismo è una ideologia abbondantemente falsa atta ad ottundere il pensiero di chi ne è permeato”, commenta, con ragione, La Grassa. 3. Aver chiarito la prospettiva di Marx, su quel rapporto sociale che è il Capitale, è essenziale per abbracciare gli sviluppi successivi, legati alle sue intrinseche contraddizioni, quelle che avrebbero azionato spinte trasformative irrimediabili, nel suo stesso grembo, fino ad una trasfigurazione intermodale verso una diversa società comunistica (in cui avviene la liberazione dei/dai bisogni), raggiunta attraverso la tappa intermedia di un socialismo, in cui ognuno avrebbe ricevuto secondo il proprio lavoro, senza sottrazioni di sorta. Dimostrato che dietro merci e valori c’è “qualcos’altro” è possibile pensare al superamento del capitalismo, non come pia aspirazione utopistica ma come dato fattuale, già esecutivo, rebus sic stantibus. Infatti, scrive Marx, il socialismo concresce nelle viscere del sistema a causa delle sue intime antinomie ed in pochi decenni (non secoli o millenni) avrebbe preso il sopravvento. Questo fa sì, precisa La Grassa, che sia possibile pensare un progetto comune di lavoro: I diversi “lavoratori privati” prendono in considerazione, im-mediata, solo il sistema dei prezzi dei vari beni, prezzi che rappresentano meri rapporti quantitativi di scambio tra merci pur espressi in equivalente generale (nelle sue varie figure monetarie). Ogni “individuo” sa soltanto che produce e vende una cosa (al limite la sua forza-lavoro) al prezzo x e che, con la quantità di moneta ottenuta, può acquistare ai prezzi y, z, w… date quantità di altre merci necessarie alla sua vita e alla riproduzione della sua forza-lavoro e delle condizioni di una nuova produzione. Afferrare che, dietro l’equivalente generale, quindi dietro determinati rapporti di scambio tra le cose prodotte, vi è un contenuto rappresentato da una quota parte del lavoro sociale complessivo, serve a comprendere che sarebbe possibile un progetto comune di lavoro, se ciò non fosse appunto impedito dalla forma di valore (o valore di scambio) in cui si esprime tale contenuto, forma che diventa generale con il modo di produzione capitalistico e induce gli “individui produttivi” ad una sfrenata competizione per prevalere gli uni sugli altri. Questo è il significato della distinzione, nella merce, di un contenuto (il valore come quota del lavoro sociale complessivo) dalla forma espressiva dello stesso, che indica la separatezza e l’autonomia dei “produttori”, costretti a soddisfare i propri bisogni – anche quelli relativi alla riproduzione allargata (accumulazione) delle condizioni (mezzi) di produzione – senza progetti di cooperazione collettiva ma anzi ponendosi in conflitto l’uno contro l’altro.
Detto ciò, è innegabile che l’ipotesi previsionale di Marx si sia scontrata con una fattualità in controtendenza andandosi definitivamente ad esaurire. Il proletariato di fabbrica non è rivoluzionario “in sé”; nemmeno i “trucchi” di Lenin (il quale parlava di Classe per sé, cioè di gruppo sociale che diventa rivoluzionario quando acquisisce una coscienza lasciandosi direzionare dalle sue avanguardie di partito, che però sono di estrazione borghese e non operaia, et pour cause) ne mutano i destini, come preventivati dalla teoria marxiana, i quali derivano dal concetto di modo di produzione capitalistico, nell’intreccio di rapporti di produzione e forze produttive, controvertiti dalle risultanze dell’effettiva dinamica capitalistica pienamente estrinsecata. Marx aveva sceverato storicamente questi elementi: inizialmente erano stati artigiani e contadini ad essere espropriati dei loro mezzi (nella fase accumulativa originaria), quest’ultimi erano divenuti proprietà di capitalisti i quali organizzavano i processi lavorativi ergendosi di fronte ad una massa di lavoratori salariati, senz’altro da offrire se non la propria energia lavorativa. Competizione e concorrenza attivano al contempo l’“autofagia” dei capitalisti tra loro. Si determina così la concentrazione e poi la centralizzazione (monopolistica) dei capitali. I capitalisti si mangiano a vicenda fino a ridursi di numero, mutando la loro funzione e divenendo meri proprietari di azioni (rentier) estranei ai processi produttivi, mentre nelle fabbriche avviene una riunificazione tra lavoratori della mente e del braccio con composizione di una nuova classe sociale (il General Intellect). Nelle stesse parole di Marx: Ogni capitalista ne uccide molti. E, di pari passo con questa centralizzazione, cioè espropriazione di molti capitalisti da parte di pochi, si sviluppano su scala crescente la forma cooperativa del processo di lavoro, la cosciente applicazione tecnica della scienza, lo sfruttamento metodico della terra, la conversione dei mezzi di lavoro in mezzi di lavoro utilizzabili soltanto in comune, l’economia di tutti i mezzi di produzione grazie al loro impiego come mezzi di produzione del lavoro sociale combinato, l’inserimento e l’intreccio di tutti i popoli nella rete del mercato mondiale, e quindi il carattere internazionale del regime capitalistico. Col numero sempre decrescente dei magnati del capitale, che usurpano e monopolizzano tutti i vantaggi di questo processo di trasformazione, cresce la massa della miseria, della pressione, dell’asservimento, della degradazione, dello sfruttamento, ma cresce anche la rivolta della classe operaia ogni giorno più numerosa, e disciplinata, unita e organizzata dallo stesso meccanismo del processo di produzione capitalistico. Il monopolio del capitale diviene un inciampo al modo di produzione che con esso e sotto di esso è fiorito. La centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono un punto nel quale diventano incompatibili col loro involucro capitalistico. Esso viene infranto. L’ultima ora della proprietà privata capitalistica suona. Gli espropriatori vengono espropriati. Il modo di appropriazione capitalistico, e quindi la proprietà privata capitalistica, nascenti dal modo di produzione capitalistico, sono la prima negazione della proprietà privata individuale poggiante sul lavoro personale. Ma la produzione capitalistica genera, con la necessità di un processo naturale, la propria negazione. È la negazione della negazione. Questa non ristabilisce la proprietà privata, ma la proprietà individuale sulla base della vera conquista dell’era capitalistica: la cooperazione e il possesso collettivo della terra e dei mezzi di produzione prodotti dallo stesso lavoro. La trasformazione della proprietà privata frammentata, poggiante sul lavoro personale degli individui, in proprietà capitalistica, è naturalmente un processo infinitamente più lungo, duro e tormentoso della trasformazione della proprietà capitalistica, che già si basa di fatto sulla conduzione sociale della produzione, in proprietà sociale. Là si trattava dell’espropriazione della massa del popolo da parte di pochi usurpatori; qui si tratta dell’espropriazione di pochi espropriatori da parte della massa del popolo (Karl Marx, Il Capitale, sez. VII, Cap. XXIV, Utet).
Il passaggio è importante perché qui Marx esplicita decisamente che la trasformazione della proprietà capitalistica, che già si basa di fatto sulla conduzione sociale della produzione, in proprietà sociale, è un avvenimento che non durerà a lungo. Il socialismo è in transizione nelle viscere del Capitale e la rivoluzione incombente avrebbe soltanto accelerato un evento necessario. Il soggetto della rivoluzione è ugualmente già formato nel processo produttivo senza alcuna utopia di supporto. Ovviamente, le classi proprietarie ancora egemoni culturalmente e politicamente (controllanti gli apparati di Stato, soprattutto quelli della coercizione) avrebbero opposto una strenua resistenza per cui si sarebbe reso necessario scalzarle dalla “macchina che gestisce la violenza” instaurando una dittatura del proletariato per liberare definitivamente la società dai parassiti finanziari. Quest’ultimi, ormai estranei alla produzione e dediti alla pura speculazione risultavano di intralcio al pieno sviluppo delle forze produttive, costrette in un involucro di rapporti socio-economici oramai deprimenti l’intera società. Il popolo avrebbe avuto, a questo punto, ben chiara l’odiosa sottrazione di pluslavoro/plusvalore, ben visibile grazie alla avvenuta riunificazione tra saperi e lavori (direzione ed esecuzione) e all’alleanza dei lavoratori del braccio e della mente, opposti ai “redditieri” estranei all’organizzazione di fabbrica, meri approfittatori del frutto del lavoro altrui attraverso le manovre sui titoli di borsa. Rotto l’involucro e dissolti i vecchi rapporti di proprietà, le forze produttive avrebbero ricominciato a svilupparsi realizzando il comunismo (passando da una breve transizione socialistica già operante nelle interiora del capitalismo), regno dell’abbondanza alla portata di tutti: “da ognuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”. La società sarebbe uscita dalla sua preistoria di sopraffazione e di strenua competizione per entrare nella Storia vera e propria, quella in cui l’uomo è finalmente affrancato dai bisogni (non intellettuali ma materiali) perché quest’ultimi sono immediatamente soddisfatti. L’umanità intera può dunque dedicarsi allo sviluppo delle sue qualità più nobili, quelle spirituali e morali, perché non vive più la stringenza del lavoro salariato, unica fonte di sostentamento subalterna ai mezzi di produzione altrui. L’ipotesi scientifico-predittiva di Marx, come si può ben desumere, non si è concretata. In nessun posto. Lo Stato accentratore della proprietà pubblica, che qualcuno definisce ancora comunista (penso alla Cina di oggi o all’Urss di una volta) in nome del proletariato non c’entra con Marx che, tutt’al più, ne vaticina la fine (o la distruzione con “spallata” rivoluzionaria) in quanto esso è per lui soprattutto accentramento dei mezzi per l’esercizio della forza, non della proprietà. “Il potere statale centralizzato, con i suoi organi dappertutto presenti: esercito permanente, polizia, burocrazia, clero e magistratura – organi prodotti secondo il piano di divisione del lavoro sistematica e gerarchica…”. Per gestire i beni collettivi basta un’amministrazione di altro tipo (poiché non sarebbero più esistite le classi e i loro conflitti, mentre le dispute interindividuali sarebbero certamente proseguite ma su tutt’altro piano), non uno Stato che è egemonia corazzata di coercizione. Un aspetto della teoria di Marx non è stato del tutto invalidato, quello che La Grassa chiama il suo “I disvelamento” (non più sufficiente però a dipanare l’attuale formazione dei funzionari privati del capitale di matrice americana) benché sappiamo benissimo che destino di ogni teoria scientifica, come diceva Weber, sia quello di essere superata. Marx ha spiegato che l’eguaglianza formale dei soggetti, scambiantisi le merci (compreso la forza lavorativa) sul mercato, al loro valore, avviene in assenza di vincoli personali. Questa parità di diritti degli attori economici sul mercato maschera però la disuguaglianza effettiva nel processo produttivo che discende dai differenziali di proprietà e, dunque, di potere tra chi detiene i mezzi produttivi e chi no. Chi non ha i mezzi vende liberamente la sua forza lavoro ma una volta inserito nella produzione produce più di quanto gli viene effettivamente pagato (è il plusvalore). Lo scambio delle merci quali equivalenti (in media) nasconde la fondamentale (sottostante) produzione, e appropriazione capitalistica, del plusvalore che è pluslavoro; ancor più decisiva è però la riproduzione del rapporto durante lo svolgimento del processo produttivo, da cui escono il capitalista, arricchito dal profitto (plusvalore), e l’operaio in quanto semplice possessore della sua forza lavoro pronta per essere rivenduta, dando così inizio ad un nuovo ciclo dello stesso processo. Tutto qui, si fa per dire! Però Marx non coglie nel segno allorché prevede l’avvento della società comunistica come parto ormai maturo (quindi da concretarsi in pochi decenni, non secoli) nelle viscere del capitalismo. Bisogna prendere atto che dalla prospettiva di Marx il comunismo è impossibile, inutile girarci intorno. Esso non si è realizzato e non si realizzerà. Tuttavia, egli non immaginava la società comunistica come un sogno, lo spiega La Grassa nel saggio, lui la vedeva già in fieri nello sviluppo delle contraddizioni capitalistiche. Chi oggi continua a sperare nel comunismo è un illuso o un imbonitore mentre Marx, lo scienziato della “scienza dei modi di produzione”, non può essere ritenuto responsabile delle immaginazioni altrui.
3. Marx aveva sempre sostenuto che il suo laboratorio era stato l’Inghilterra, in quanto sede classica del modo di produzione capitalistico, cioè dei rapporti di produzione e di scambio ad esso corrispondenti. Tuttavia, già a fine ottocento e primi novecento il suo modello teorico, di fronte alla formazione dei grandi monopoli, cominciò a vacillare. Si erano formate grandi imprese (organismi composti da dipartimenti, settori, reparti ecc. ecc.) che non erano semplicemente le fabbriche che egli aveva avuto sotto gli occhi. In questi conglomerati produttivi e finanziari, estremamente articolati, la separazione tra manager e giornalieri è fin troppo evidente, per non parlare di tutta quella serie di ruoli (e funzioni) intermedi che vengono a stratificarsi tra gli uni e gli altri. La presagita sintesi dei saperi produttivi, la riunificazione tra operazioni intellettuali e manuali, resta un miraggio, anzi, al contrario si accelera la costituzione di una managerialità specialistica di elevato ingegno e doti strategiche, sospinta dalla tecnica, dalle innovazioni di prodotto (e non solo di processo), contrapposta di fatto agli operai. Questo mutamento obbliga ad un detour ideologico, il “soggetto rivoluzionario” non è più l’unione di dirigenti e operai, ma le sole tute blu mentre i “responsabili della produzione” sono considerati specialisti borghesi, soggetti inclini ad indentificarsi con le classi superiori che il proletariato deve tenere sotto stretto controllo “con i fucili puntati alla schiena” (Lenin). Con la descritta situazione viene a decadere la possibilità di una effettiva preponderanza sociale degli “sfruttati” sul grosso della società. La teoria leniniana dell’avanguardia, che include quella parte degli “intellettuali borghesi giunti alla comprensione del movimento della società nel suo insieme” (Marx) e la parte più cosciente degli operai, tenta proprio di colmare questo deficit egemonico. Le rivoluzioni guidate da simili avanguardie, in paesi dove erano i capitalisti ad essere più deboli e non i subordinati ad essere più forti, hanno ottenuto certo dei risultati ma non quelli sperati e, in ogni caso, nessuna costruzione del socialismo o del comunismo. Da simili rivolgimenti sono nati anche nuovi rapporti sociali che però, alla lunga, si sono dimostrati meno dinamici di quelli capitalistici, tanto da portare al fallimento delle società che li avevano instaurati (Unione Sovietica). Sinceramente, c’è anche da dire che lo stesso capitalismo, quello inizialmente tracciato da Marx, a partire dall’epoca dell’imperialismo, si è tramutato in qualcosa di diverso. Per questo il marxismo ha cominciato a mancare costantemente il “bersaglio”. La Grassa suggerisce la presenza di questa transizione e la fa coincidere con la supremazia americana, sospinta dalla strutturazione interna di quella formazione, nella quale si profila la genesi dei funzionari (privati) del capitale, diversa da quella inglese, preminente fino alla fine del ’800 inizio ’900. Gli Usa, che si rafforzeranno dopo due guerre mondiali, sconfiggeranno infine anche il “socialismo reale” e rimondializzeranno il pianeta imponendo a tutti il marchio del loro predominio.
4. Il mutamento storico impone ora un rinnovamento teorico perché il vecchio marxismo risulta inadatto ad interpretare la nuova realtà. Il capitalismo borghese, con laboratorio nella sua sede inglese, è metamorfosato in una direzione non prevista dal “Moro”, non è stato soppiantato dal comunismo di cui gli “sfruttati” erano classe intermodale di trapasso. Sulla base di queste considerazioni e dell’evoluzione, politica, sociale, culturale ecc. ecc. degli eventi l’analisi deve essere riorientata. La Grassa lo sostiene francamente: Mi sono quindi posto il compito di individuare la fallacia delle previsioni formulate in base alla teoria cui avevo aderito, attribuendola alla centralità che Marx aveva assegnato a: 1) la produzione (non nelle sue tecniche bensì nei suoi rapporti sociali) quale “base” sostanziale e struttura portante della società; 2) la divisione di quest’ultima in due classi antagoniste, la cui lotta doveva rappresentare la dinamica di quei rapporti e spingerli infine ad una trasformazione secondo un orientamento che sarebbe stato possibile individuare con certezza; classi caratterizzate, in modo preciso e inequivocabile, dalla “proprietà” (potere di disporre) o “non proprietà” dei mezzi impiegati nella produzione…Ho spostato la centralità in questione ponendola nel conflitto tra strategie (che sono l’essenza della POLITICA nel suo significato più generale, che non è quello della sfera di apparati designati con questo nome) applicate da diversi (non semplicemente due) gruppi sociali allo scopo di conseguire la supremazia in quella data formazione sociale e per una determinata epoca storica. Ho illustrato più volte quali conseguenze derivino da questo spostamento di centralità per quanto riguarda l’analisi della società, con particolare riferimento a quella detta capitalistica; e che credo nasconda il succedersi di almeno due formazioni sociali nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, da quando Marx diede la sua definizione di rapporto sociale (di produzione) capitalistico. Ho definito queste due formazioni: capitalismo borghese (tipico del primo paese compiutamente capitalistico, l’Inghilterra) e società dei funzionari, o meglio ancora strateghi, del capitale (affermatasi più compiutamente negli Stati Uniti dopo la loro guerra civile e in particolare nella prima metà del XX secolo).
Dopo una lunga epoca, caratterizzata da pesanti crisi economiche (si indicano in particolare, la Grande Stagnazione del 1873-’96 e il crollo del 1929) e due dispute mondiali (nonché quasi mezzo secolo di confronto bipolare Usa-Urss conclusosi nel 1989-91), gli Stati Uniti, portatori di una formazione sociale differente da quella del capitalismo di matrice inglese, benché avente una struttura sempre fondata su mercato e impresa, hanno raggiunto un primato assoluto in quasi ogni campo. In questo contesto, di pesanti rivolgimenti geo-politici, la lotta di classe (il conflitto Capitale/Lavoro – proprietari/non proprietari dei mezzi di produzione), i contrasti nella base economico-produttiva, su cui Marx basava parte del suo discorso, sono apparsi assolutamente secondari rispetto al resto. L’economia quale determinazione di ultima istanza per “leggere il capitale” è venuta a mancare. Le lotte tra i gruppi dominanti nella società globale, quelle orizzontali tra decisori di paesi diversi e quelle verticali tra gruppi dominanti all’interno di uno stesso contesto nazionale, hanno dimostrato di essere peculiarmente innervanti la dinamica sociale complessiva. Per tanto, l’autore di questo saggio, ha voluto porre l’accento sullo scontro tra agenti capitalistici, tra Stati e loro tessuti di connessione collettiva che vanno analizzati nell’insieme delle sfere sociali: economica (produttiva e finanziaria), politica (con le sue propaggini militari e d’intelligence), ideologico-culturale. I fatti della sfera economica non sono assolutizzanti, nonostante prendano spesso il davanti della scena, quanto più “volatili” appaiano. Essi sono funzionali ad una battaglia per la prevalenza, da attuarsi attraverso un confronto strategico, vero centro della questione.
Ma puntualizziamo meglio. “Politico” è tutto ciò che attiene alle strategie per primeggiare nei vari contesti umani. Per tale ragione, La Grassa, parla della POLITICA, non come insieme di apparati dell’omonima sfera o di agonismo per scopi elettorali (la sciocca democrazia da paragonarsi ad un sondaggio tra gli aventi diritto per offrire a quest’ultimi l’abbaglio di una partecipazione o lo “smercio” di una allucinazione che finga di rappresentarli nei loro interessi) , ma quale “strategia”, “serie successiva di mosse strategiche”, per affermare la propria visione delle cose e del mondo. Chi pensa meglio la propria situazione e si muove di conseguenza, in un campo di possibilità individuate astrattamente (perché si tratta di una costruzione della realtà tramite delle idee rigorose e non di una riproduzione fedele della materialità nel cammino del pensiero) e stabilizzate ai fini dell’azione, raggiunge una certa prevalenza (sociale, culturale, organizzativa, economica, ecc. ecc.) più o meno duratura ma non permanente, nell’ambito di quella data formazione sociale, logisticamente individuata. La POLITICA, intesa in tal guisa, è una modalità teorico-pratica (strategia e azione), per incidere nel quadro sociale, nelle sue segmentazioni e stratificazioni, nelle sue concrezioni più visibili che per comodità espositiva possono essere ridotte alle tre sfere citate. Questa riflessione ci libera dal “suprematismo” dell’economico, dalla “teologia” del denaro e dei suoi duplicati finanziari ma anche dalla teleologia marxiana secondo cui gli sconvolgimenti nella struttura economica della società (rapporti di produzione+forze produttive=modo di produzione, la presunta base reale, come se gli aspetti da Marx stesso definiti sovrastrutturali fossero irreali o non abbastanza reali) sono quelli fulcrali per aprire una fase di palingenesi nel corpo collettivo. L’approntamento delle strategie per raggiungere un predominio necessita di “energie” per sostenere i conflitti, oltre che della capacità pre-visionale per circoscrivere il migliore “campo” dove sfidarsi. Nella società capitalistica, il terreno economico viene sicuramente in maggiore evidenza per le caratteristiche del sistema il quale, come scriveva Marx, si presenta come un’immane raccolta di merci. La centralità dei mercati, sostenuta dal (neo)liberismo, da cui è oggi scaturita la globalizzazione mercantile, fa parte di questa visione superficiale. Tale approccio, in conseguenza dei suoi postulati, dà grandissima (troppa) importanza al “denaro”, quale equivalente generale, poiché esso “paga” il prezzo di tutto e chi ne dispone a sufficienza può comprare cose e persone da utilizzare nello scontro con gli avversari. La narrazione dominante obnubila, inoltre, il vero conflitto per la supremazia, che avviene tendenzialmente senza esclusione di colpi ma “riparato” sotto le virtù “concorrenziali” e “competitive” che, ispirate dalla mano invisibile, consentirebbero al più abile o meritevole – perché capace di fornire alla società beni e servizi di alta qualità a costi contenuti (il principio della razionalità strumentale, il minimax, minimo mezzo e massimo risultato) – di accedere ai più alti ranghi del benessere e del prestigio. Il neoliberismo crede, pertanto, che tutto debba essere lasciato al mercato, con decisa riduzione dell’intervento dello Stato in economia, in quanto i suoi meccanismi intrinseci sono in grado di auto-correggere gli eventuali squilibri tra domanda e offerta, portando prosperità a tutta la civiltà. Questa è una posizione ingenua per due ordini di ragioni. Presuppone che la razionalità strumentale risolva ogni orizzonte umano (ignorando che i saperi strategici precedono e indirizzano le scelte economiche e non solo quelle), inoltre, occulta il ruolo svolto dai Paesi più avanzati, militarmente e tecnologicamente, nel dettare le leggi che influenzano i rapporti mercantili. La potenza, invece, permette a chi la detiene di fare e interpretare le regole a proprio favore e piacimento. Peraltro, non è affatto vero che il mercato sia il deus ex-machina che vogliono farci credere. In un saggio notevole, l’economista coreano Ha-Joon Chang tratta il tema del rapporto imprese-mercato in questi termini:
Con lo sviluppo del capitalismo, settori sempre più vasti dell’economia sono stati dominati da grandi società. Questo significa che è cresciuta l’area dell’economia capitalista coperta dalla pianificazione. Per fare un esempio concreto, oggi una porzione compresa tra un terzo e la metà del commercio internazionale, a seconda delle stime, è fatta di trasferimenti tra differenti unità all’interno di società transnazionali. Herbert Simon, un pioniere degli studi di organizzazione delle imprese, riassunse sinteticamente questo punto nel 1991 in Organisations and Markets, uno degli ultimi articoli da lui scritti. Se un marziano, senza pregiudizi, venisse sulla terra e osservasse la nostra economia, scherzava, penserebbe forse che i terrestri vivono in un’economia di mercato? No, diceva, concluderebbe quasi certamente che i terrestri vivono in una organizational economy (economia organizzativa), nel senso che il grosso delle attività economiche della terra sono coordinate, all’interno delle aziende (organizzazioni), piuttosto che tramite transazioni di mercato tra aziende diverse. Se le aziende fossero rappresentate dal verde e i mercati dal rosso, diceva Simon, il marziano avrebbe visto “grandi spazi verdi interconnessi da linee rosse”, piuttosto che “una rete di linee rosse che connettono spazi verdi”. E noi pensiamo che la pianificazione sia morta. Simon non includeva la pianificazione statale, ma se l’aggiungiamo le moderne economie capitaliste sono ancora più pianificate di quanto suggerito dalla prospettiva del marziano. Tra la pianificazione all’interno delle imprese e i vari modelli di pianificazione statale, le moderne economie capitaliste risultano essere pianificate in misura molto elevata. Un punto interessante da sottolineare è che i paesi ricchi sono più pianificati dei paesi poveri, data l’ampia presenza di grandi società, e spesso la più diffusa presenza dello stato (anche se in genere meno visibile, dato il suo approccio più sottile). ( Ha-Joon Chang, 23 cose che non ti hanno mai detto sul capitalismo, Il Saggiatore).
In questa sede non ci interessa tanto l’aspetto della cosiddetta pianificazione capitalistica, che pur è rilevante, ma un altro tema che l’economica dominante tende a ideologizzare con spiegazioni di comodo: il rapporto tra imprese e mercato, “appianato” ricorrendo a sotterfugi quasi spiritistici, come la mano invisibile di smithiana memoria, quale specie di “orologio biologico” del sistema economico che regola tutti i suoi ritmi. Per l’economia mainstream le imprese operano nel mercato ma risultano separate da questo. Sono immerse in esso come corpi avulsi che ne subiscono gli impulsi e i condizionamenti ad ogni livello. Il primo sarebbe pertanto l’ambiente esterno delle seconde, un habitat che con le sue leggi universali e imperiture, prima fra tutte la concorrenza, norma le attività di tali apparati privati. Ma è proprio così? Simon, con il suo esempio delle zone verdi (imprese) interconnesse da linee rosse (mercati) coglie intuitivamente qualcosa in più anche se non giunge al punto. Almeno però respinge l’idea superficiale del mercato come ambiente altro dagli attori collettivi che vi opererebbero “dentro”. Ma esiste realmente un dentro ed un fuori dal mercato? Per l’economica ufficiale, che intende lo spazio mercantile come superficie piana su cui si collocano singolarità imprenditoriali fondamentalmente speculari, ed aventi un potere tendenzialmente equivalente (valendo le leggi quasi perfette della competizione), ovviamente sì. Ma se tale “spazio” viene inteso come una sfera nella quale si snodano trame conflittuali tra più soggetti che operano per conquistare una posizione di predominio (tanto sociale e politico che economico), allora no o non del tutto. Se la seconda ipotesi è verosimile anche l’interconnessione simoniana appare inadeguata a spiegare tutta la “faccenda”. L’economia organizzativa, comunque fondata sulla razionalità strumentale (minimo mezzo – massimo risultato, con opportuni correttivi che tengano conto degli obiettivi di lungo periodo, in ossequio ai quali è lecito e possibile accettare piccole perdite immediate per una maggiore stabilità futura, quindi contravvenendo occasionalmente al modello per un miglioramento organizzativo), non coglie il vero lavoro strategico che le imprese svolgono per affermarsi sulle altre. Le sole strategie economiche risultano insufficienti per spuntarla sui competitori essendo i profitti, in un contesto capitalistico pienamente sviluppato, uno strumento per confliggere e primeggiare e non l’obiettivo “esistenziale dell’impresa” tout court. Un’impresa dominante (parliamo soprattutto dei grandi giganti del mercato) non resta mai tale se non è in grado di innovare continuamente ma pure se non è capace di far fuori gli avversari con manovre extraeconomiche. Anche a questo serve la sua “intelligence” interna. Carpire i segreti del “nemico”, elaborare strategie “di guerra” servendosi di tutti i mezzi a disposizione, inclusi i legami istituzionali, e, perché no, quelli “delinquenziali” ecc. ecc. La Grassa, invece, illustra magistralmente questi concetti. Egli dice che nell’impresa operano due diversi tipi di razionalità. I marxisti, ma anche gli economisti “sistemici”, hanno sempre pensato che ruolo precipuo dell’impresa (nella sua riduzione a fabbrica) fosse quello di garantire la migliore combinazione dei fattori produttivi (capitale e lavoro) al fine di produrre, con le risorse a disposizione, il massimo possibile. Questa razionalità del minimax agisce, senza ombra di dubbio, dal lato tecnico-produttivo, essendo la stella polare che orienta l’azione dello “strato” che si occupa degli esiti della produzione e nella quale sono implicati (in maniera subordinata) anche i lavoratori (più e meno qualificati). Già questo mette in evidenza che il gruppo dei tecnici e degli ingegneri, deputati agli indirizzi produttivi, è direttamente collegato al comando del management strategico, dal quale riceve precisi input che devono essere convertiti lungo gli anelli della catena dell’impresa (riorganizzazioni processuali con impiego di tecnologie sempre più avanzate, ma anche per la realizzazione di nuovi output) con lo scopo di aumentare la produttività del lavoro.
I lavoratori subordinati, meri esecutori degli ordini provenienti dal settore tecnico-ingegneristico, non hanno alcuna possibilità di intervenire su questi processi poiché sono inseriti in attività lavorative fortemente parcellizzate o direttamente guidate dalla combinazione “macchinica”. La conoscenza globale del processo produttivo (i c.d. saperi produttivi), dal lato tecnico, è prerogativa degli specialisti della produzione, almeno per quel che concerne intere sezioni o dipartimenti nei quali l’impresa è scorporata; questo sapere non è uniforme e si ripartisce, a sua volta, tra i vari specialisti che dirigono tecnicamente i diversi settori aziendali. Anzi, contrariamente a quanto affermava il marxismo economicistico, il sapere all’interno della produzione non tende ad omogeneizzarsi e a diffondersi capillarmente lungo la collana dei profili lavorativi, “lo specialismo” tende, invece, a moltiplicarsi con una progressione geometrica. La razionalità strategica, al contrario, attiene esclusivamente ai gruppi di comando che guidano le imprese (proprietà o disposizione sui mezzi produttivi), i quali gestiscono il coordinamento tra le varie parti (dipartimenti) ed orientano le risorse esitate dal lavoro sottostante nella lotta per la preminenza nell’ambiente “esterno”. Questo ambiente esterno non coincide semplicemente col mercato ma è qualcosa di molto più complesso che comprende anche la politica e le influenze ideologiche. Il mercato stesso non è il luogo che comincia dove finisce l’impresa o, più scarnamente, quello dove le imprese si scontrano per vendere i loro prodotti (senz’altro anche questo). Il mercato è direttamente nell’impresa così come l’impresa è immersa nel mercato:
[…] nelle relazioni tra le sue varie parti (sezioni, dipartimenti, divisioni) che sono di tipo sia più propriamente gerarchico sia caratterizzate da determinate forme di decentramento e flessibilizzazione dell’organizzazione intera; per cui quest’ultima si basa su ordini imperativi, sul coordinamento imposto dall’alto verso il basso, ma anche su rapporti interimprenditoriali.
Come si può ben capire, La Grassa sposta completamente il fulcro dell’analisi dalla fabbrica – intesa come organismo unitario che si limita a trasformare dati input in dati output, secondo la combinazione dei fattori produttivi e i metodi del plusvalore (in primis “relativo”) – all’impresa, che è invece “un aggregato, internamente coordinato dal gruppo di comando, di entità produttive, disposte generalmente su linee collaterali, ma che nel loro complesso configurano una piramide gerarchica di funzioni e ruoli sociali.” (La Grassa, Microcosmo del dominio, CRT). Dunque,
non è né l’ottimale combinazione dei fattori produttivi, secondo i dettami dell’economica neoclassica, né il massimo profitto da ottenere con i metodi del plusvalore soprattutto relativo… così come sostenuto dal marxismo tradizionale. A parità di ogni altra condizione, si persegue l’efficienza economica, cioè il principio della massima economizzazione dei mezzi, ma solo se questa è in accordo con l’efficacia dell’attività svolta per prevalere nell’ambiente mercantile, uno spazio i cui confini e la cui trama interrelazionale interna sono tracciati dalle azioni conflittuali delle varie imprese in reciproca lotta. L’efficienza tende a conseguire il massimo profitto (plusvalore) che rappresenta il fondo cui attingere per svolgere con efficacia la competizione interimprenditoriale. Essendo però il successo in quest’ultima il fine principale perseguito da ognuno dei molti capitali in conflitto per la preminenza, l’efficacia è prioritaria rispetto all’efficienza… l’efficacia nella lotta, e dunque la prevalenza conseguita tramite questa, è il fine supremo di ogni funzione capitalistica; l’efficienza nell’organizzazione interna ad ogni impresa – e dunque il perseguimento di quello scopo secondario che è il massimo profitto da conseguire con il miglior uso di dati mezzi (economica neoclassica), o con l’estrazione del massimo plusvalore da una data forza lavoro (marxismo) – è un semplice mezzo in relazione allo scopo principale, di carattere strategico e decisivo. Accade spesso che l’efficienza… entri in contraddizione con il fine principale, quello della migliore strategia per… conseguire la supremazia. In questo caso, si può ben sacrificare l’efficienza, si possono “sprecare” risorse, non seguendo perciò il principio (neoclassico) dell’economicità né quello (marxista) dell’estrazione del massimo pluslavoro/plusvalore (G. La Grassa, Gli Strateghi del Capitale, Manifestolibri).
Questo è, onestamente, un passo avanti nel tentativo di comprendere le categorie essenziali dei capitalismi odierni che gli economisti di “regime” trasformano in idòla, utili alle loro carriere ma inutili al resto dell’umanità.
5. Il discernimento della situazione nel “campo di stabilità” è una questione complessa che non si rende intelligibile ricorrendo alle “specifiche” della razionalità strumentale; occorre invece la capacità di orientarsi nel mondo dell’agente strategico. Per raggiungere la preminenza, in ciascuna delle sfere sociali in cui si è suddivisa la realtà, ci vuole “scienza, conoscenza e arte”, in quanto non è sol(tanto) questione di calcoli, di analisi costi-benefici, anzi, lo stratega può lungamente derubricare l’utilità immediata per raggiungere obiettivi più alti, appunto strategici, in momenti successivi. La razionalità strumentale procura sicuramente le risorse con le quali è poi possibile scontrarsi coi nemici per primeggiare. Ma non è il nocciolo della questione, l’elemento vitale che avrebbe acceso la divaricazione “bipolare” (lavoratore collettivo cooperativo, inglobante il gran numero delle funzioni e degli individui vs speculatori sparuti ma controllanti la “bestia statale”), tra classi nemiche a prescindere dai contesti nazionali o culturali, contrariamente a quello che pensava Marx, il quale è comunque lungimirante da scorgere: Il costante accrescimento delle classi medie che si trovano nel mezzo, fra gli operai da una parte e i capitalisti e i proprietari fondiari dall’altra, in gran parte mantenute direttamente dal reddito, e che gravano come un peso sulla sottostante base lavoratrice e accrescono la sicurezza e la potenza sociale dei diecimila soprastanti (Karl Marx, Teorie sul plusvalore, vol. II). Lo svolgimento preventivato da Marx non si è concretato, la società odierna non ha visto affatto scomparire i suoi corpi intermedi perché assorbiti dalla classe “sottostante” (a sua volta non unificatasi e allargatasi agli alti ranghi ingegneristici ma ridottasi persino di numero nelle sue schiere operaie), il “diaframma” delle classi medie si è mostrato molto flessibile, consustanziale all’esistenza dei capitalismi e non destinato a dissolversi, offerente agli strati superiori, e non a quelli salariati di infimo status, le sue teste preparate. Il concetto stesso di “medietà” di tali corpi è divenuto ripostiglio di incomprensioni e di scarsa propensione allo studio dei cambiamenti sociali. Il conflitto strategico cerca di afferrare tutti questi aspetti (novità) e prova a superare l’impasse in cui è precipitato il marxismo. La razionalità strategica, il conflitto strategico (precipuamente quello nei gangli del comando) schiude finalmente la Storia a inconsuete e originali esegesi, sempre meglio della solita “solfa” sulla lotta di classe che non rende più perspicua la nostra contemporaneità e garantisce rifugio a molte canaglie, sedicenti rivoluzionarie ma passate al nemico senza autocritica. Il sol dell’avvenire non viene ed è meglio farsene una ragione piuttosto che insistere utopisticamente con teorie fintamente emancipative e degradate a religioni, professate da approfittatori della credulità popolare. La Grassa, comunque, ammette che in Marx, esisteva un elemento oggettivo convincente (la proprietà, il potere di disposizione, o non proprietà dei mezzi di produzione) che stabiliva in anticipo (e non come discettava Althusser durante il reciproco confronto) gli schieramenti sociali e le modalità di trapasso da una formazione sociale all’altra (schiavismo, feudalesimo, capitalismo). La Storia (era) esattamente storia di lotte di classe. Ma i processi storici di transizione, che vengono colti ex-post, non sono una necessità oggettiva della Storia medesima. Sono accaduti e vengono riscontrati ma è improbo definirne lapalissianamente la “ragione” causante. Forse la nostra ragione è più adatta a scorgere l’intersoggettività sociale, anche quella dei conflitti, per quanto debba sforzarsi di porre un “principio originario” (che non è semplicisticamente un mito fondativo), come ha fatto Marx elaborando la nozione dell’accumulazione originaria. Il conflitto strategico può essere allora coerentemente posto al centro dell’evoluzione storica delle formazioni sociali. Il conflitto dà “tono” all’agire e crea le masse d’urto per le “battaglie” dalle quali, infine, escono vincenti e perdenti, con conseguente riparametrazione dei rapporti di forza i quali, tuttavia, non si danno una volta per tutte col medesimo “settaggio”. La Storia non muore mai, non si placa, perché lo squilibrio incessante del “reale” è il suo motore. Tale squilibrio, dettato dal fluire caotico del reale, può ben essere, mutatis mutandis, la nostra “accumulazione originaria”. Il flusso è pensato, o meglio, immaginato (con la creatività delle forme artistiche) ma non può essere attraversato. Immersi in esso ci sentiremmo alla deriva, come nel cosmo sconfinato. Per agire nello scorrimento del tempo e dello spazio (sociali) i gruppi devono creare campi di stabilità in cui muoversi (razionalmente) con l’intento di conseguire scopi. Meta delle mete è la supremazia sugli altri contendenti che nasce dalla convinzione di avere convinzioni più adatte al progresso particolare e generale. Le élites o avanguardie sorgono su questi presupposti. I drappelli decisori (i quali devono, in ogni caso, associare alla propria progettualità blocchi consistenti di popolazione per avere “massa” d’impatto), che egemonizzano un dato campo di stabilità, avvertono il pericolo di potenziali rivali pronti a scalzarli, sentendosi anche questi portatori di sorti ancor più magnifiche e progressive di quelle istituite. Si alimentano così “movimenti vari di conflitto e di alleanza (ma ai fini del conflitto poiché, come si dice, l’‘unione fa la forza’) tra gruppi vari”. Il flusso squilibrante del reale sospinge i gruppi ad affrontarsi, i conflitti diventano inevitabili a lungo andare, imponendo il traguardo della supremazia ai vari livelli: economico, politico, ideologico-culturale. La POLITICA nel senso di serie di “mosse strategiche” è, pertanto, il perno di questo “gioco” senza fine (della Storia).
Continua a leggereVi presentiamo le discussioni di La Grassa su Karl Marx. Le “lezioni” approfondiscono molti temi sviluppati in questi anni dal pensatore veneto sulla teoria marxiana, non per ristabilire la “verità” su quel che Marx avrebbe detto esattamente ma per eliminare i troppi fraintendimenti che ancora oggi obnubilano il nucleo essenziale dei suoi studi sul capitalismo a matrice inglese. Tali errori forniscono una cattiva interpretazione del passato e si ripercuotono anche sulla comprensione del presente che, invece, necessita di un nuovo apparato categoriale di riferimento per essere inteso nei suoi elementi essenziali. Seguire l’esempio di Marx vuol dire proprio far progredire la scienza sociale, superando i dogmatismi e i preconcetti, soprattutto quelli di un marxismo ormai ossificato e lontano dalla realtà. La Grassa opera questo tentativo individuando gli elementi decisivi per Marx e quanto si è, invece, sviluppato antiteticamente alle sue ipotesi predittive.
Continua a leggere
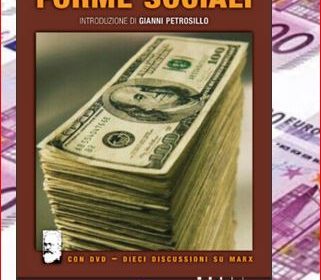
Qui di Gianfranco La Grassa Indice: Introduzione, di Gianni Petrosillo pag. 9 Denaro e forme sociali pag. 27 Appendice: il marxismo impossibile pag. 41 Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che io posso pagare, ciò […]
Continua a leggere
Ogni tanto, nonostante si tratti di questioni chiuse da un pezzo, qualcuno riesuma il “povero” Proudhon per opporlo a Marx. Viene detto che seguendo le idee del primo il socialismo non sarebbe mai degenerato nel terrorismo rosso e nel leninismo burocratico di Stato che raggiunse l’apice con le atrocità collettivistiche di Stalin. Sono tutte sciocchezze sesquipedali ripetute da pseudo intellettuali prezzolati i quali celano le proprie incomprensioni teoriche dietro belle ma inutili parole come la solidarietà sociale. L’episodio emblematico fu quello del ‘78 allorché il Psi, assistito da due mediocri personaggi, Luciano Pellicani e Luciano Cafagna, tirò fuori un inesistente Proudhon mezzo liberale e mezzo craxiano per criticare il “violento e intollerante Marx”. L’operazione fu talmente carnevalesca, benché supportata da contingenti esigenze politiche, che chi la eseguì sentirà per sempre ridersi alle spalle finché vivrà ed anche oltre. Eppure Marx, con molta tristezza, non poté fare a meno di mettere Proudhon di fronte alle sue contraddizioni pur avendo avuto iniziale stima di lui. Proudhon stava facendo troppa confusione tra filosofia ed economia, nonostante Marx gli avesse riconosciuto il merito di aver aperto il suo linguaggio alla modernità economica. Tuttavia: “Proudhon non ha che idee imperfette, confuse e false circa il fondamento di ogni economia politica, il valore di scambio: il che lo conduce a vedere le basi di una nuova scienza in una interpretazione utopistica della teoria del valore di Ricardo. Infine io riassumo il mio giudizio generale sul suo punto di vista con queste parole: ‘ Ogni rapporto economico ha un lato buono e uno cattivo: è questo l’unico punto sul quale Proudhon non si smentisce. Il lato buono egli lo vede esposto dagli economisti; quello cattivo lo vede denunciato dai socialisti. Egli prende a prestito dagli economisti la necessità dei rapporti eterni; dai socialisti l’illusione di vedere nella miseria solo la miseria” (invece di vedervi l’aspetto rivoluzionario, distruttivo che rovescerà la vecchia società). “E si trova d’accordo con gli uni e con gli altri, volendosi appoggiare all’autorità della scienza, che, per lui, si riduce alle esigue proporzioni di una formula scientifica; è l’uomo alla ricerca delle formule. Quindi Proudhon si vanta di aver fornito la critica e dell’economia politica e del comunismo: mentre si trova di sotto dell’una e dell’altro. Al di sotto degli economisti, poiché come filosofo che ha sotto mano una formula magica, ha creduto di potersi esimere dall’entrare in dettagli puramente economici; al di sotto dei socialisti, poiché non ha né sufficiente coraggio né sufficienti lumi per elevarsi, non fosse altro in maniera speculativa, oltre l’orizzonte borghese… Vuole librarsi, come uomo di scienza al di sopra dei borghesi e dei proletari; e non è che il piccolo borghese, sballottato costantemente fra il capitale e il lavoro, fra l’economia politica e il comunismo’. ” (Marx)
Dunque, checché ne dica Pellicani, il pensiero di Proudhon non sarebbe servito per “l’universalizzazione dei valori liberali, non già la loro negazione; la socializzazione del mercato, non già la sua distruzione; la saldatura fra democrazia economica e democrazia politica, non già la tirannia ideocratica dei custodi sacerdotali della Gnosi dialettica”.
Questi sono giudizi in libertà di chi ha voluto compiacere le mode dei propri tempi per conciliare l’inconciliabile. Anzi, Marx critica in Proudhon, l’assoluta mancanza di contatto con la realtà: “A sentir lui, l’uomo non è che lo strumento di cui l’idea ovvero la ragione eterna si serve per svilupparsi. Le evoluzioni di cui parla Proudhon debbono essere evoluzioni quali si compiono nel seno mistico dell’idea assoluta. Ma se si strappa il sipario di questo linguaggio mistico, ciò significa che Proudhon ci fornisce l’ordinamento in cui le categorie economiche si sistemano all’interno del suo cervello”.
Più grave però è che i comunisti di ieri e i nostalgici di oggi non abbiano capito che per il pensatore tedesco la proprietà non fosse un furto. In ciò sono stati Proudhoniani anziché marxisti senza nemmeno rendersene conto.
Tanto Engels che Marx furono precisi sul punto:
“Se si traducono i giuochi di prestigio della produzione capitalistica in questo linguaggio semplice, nel quale essi si manifestano apertamente come furto, si rendono impossibili. (Engels)
“Poiché il ‘furto’in quanto violazione della proprietà presuppone la proprietà, così Proudhon ha finito col perdersi in confuse e cervellotiche discettazioni sulla vera proprietà borghese”.
Persino nel film “Le jeune Karl Marx” del 2017, di Raoul Peck, c’è una bellissima scena in cui Marx incontra Proudhon e chiede spiegazioni sulla proprietà che sarebbe un furto. Qui Marx dice”se rubo la proprietà di qualcuno sto rubando un furto?” Una battuta che fulmina Proudhon. https://m.youtube.com/watch?v=abeNVdxLvTg
In nessun caso la proprietà si fonda sul furto, come sosteneva Proudhon, e non sono rapine quella che avvengono nella produzione, di beni o di servizi, o nei mercati azionari. Non è un gioco delle tre carte quello finanziario. I cervelli banali dei filosofi lo pensano. Lo spiega perfettamente Engels nell’ Anti-Dühring (la citazione è lunga ma necessaria):
<<In generale la proprietà privata non appare affatto nella storia come risultato della rapina e della violenza. Al contrario. Essa sussiste già, anche se limitatamente a certi soggetti, nella comunità primitiva naturale di tutti i popoli civili. Già entro questa comunità essa si sviluppa, dapprima nello scambio con stranieri, assumendo la forma di merce. Quanto più i prodotti della comunità assumono forma di merci, cioè quanto meno vengono prodotti da essa per l’uso personale del produttore e quanto più vengono prodotti per il fine dello scambio, quanto più lo scambio soppianta, anche all’interno della comunità, la primitiva divisione naturale del lavoro, tanto più diseguali divengono le fortune dei singoli membri della comunità, tanto più profondamente viene minato l’antico possesso comune del suolo, tanto più rapidamente la comunità si spinge verso la sua dissoluzione e la sua trasformazione in un villaggio di contadini parcellari. Per secoli il dispotismo orientale e il domino mutevole di popoli nomadi conquistatori non poterono intaccare queste antiche comunità; le porta sempre più a dissoluzione la distruzione graduale della loro industria domestica naturale operata dalla concorrenza dei prodotti della grande industria. Così poco si può parlare qui di violenza, come se ne può parlare per la sparizione che avviene anche oggi dei campi posseduti in comune dalle “Gehöferschaften” [comunità di villaggio] sulla Mosella o nello Hochwald; i contadini trovano che è precisamente nel loro interesse che la proprietà privata del campo subentri alla proprietà comune. Anche la formazione di un’aristocrazia naturale, quale si ha nei celti, nei germani e nel Punjab basata sulla proprietà comune del suolo, in un primo tempo non poggiò affatto sulla violenza, ma sul consenso e sulla consuetudine. Dovunque si costituisce la proprietà privata, questo accade in conseguenza di mutati rapporti di produzione e di scambio, nell’interesse dell’aumento della produzione e dell’incremento del traffico: quindi per cause economiche. La violenza qui non ha assolutamente nessuna parte. È pur chiaro che l’istituto della proprietà privata deve già sussistere prima che il predone possa appropriarsi l’altrui bene; che quindi la violenza può certo modificare lo stato di possesso, ma non produrre la proprietà privata come tale. Ma anche per spiegare “il soggiogamento dell’uomo allo stato servile” nella sua forma più moderna, cioè nel lavoro salariato, non possiamo servirci né della violenza, né della proprietà fondata sulla violenza. Abbiamo già fatto menzione della parte che, nella dissoluzione delle antiche comunità, e quindi nella generalizzazione diretta o indiretta della proprietà privata, rappresenta la trasformazione dei prodotti del lavoro in merci, la loro produzione non per il consumo proprio, ma per lo scambio. Ma ora Marx ha provato con evidenza solare nel “Capitale”, e Dühring si guarda bene dal riferirvisi sia pure con una sola sillaba, che ad un certo grado di sviluppo la produzione di merci si trasforma in produzione capitalistica, e che in questa fase “la legge dell’appropriazione poggiante sulla produzione e sulla circolazione delle merci ossia legge della proprietà privata si converte direttamente nel proprio diretto opposto, per la sua propria, intima, inevitabile dialettica. Lo scambio di equivalenti che pareva essere l’operazione originaria si è rigirato in modo che ora si fanno scambi solo per l’apparenza in quanto, in primo luogo, la quota di capitale scambiata con forza-lavoro è essa stessa solo una parte del prodotto lavorativo altrui appropriato senza equivalente, e, in secondo luogo, essa non solo deve essere reintegrata dal suo produttore, l’operaio, ma deve essere reintegrata come un nuovo sovrappiù (…) Originariamente il diritto di proprietà ci si è presentato come fondato sul rapporto di lavoro (…) Adesso” (alla fine del suo sviluppo dato da Marx) “la proprietà si presenta, dalla parte del capitalista come diritto di appropriarsi lavoro altrui non retribuito ossia il prodotto di esso, e dalla parte dell’operaio come impossibilità di appropriarsi il proprio prodotto. La separazione tra proprietà e lavoro diventa conseguenza necessaria di una legge che in apparenza partiva dalla loro identità” In altri termini: anche se escludiamo la possibilità di ogni rapina, di ogni atto di violenza, di ogni imbroglio, se ammettiamo che tutta la proprietà privata originariamente poggia sul lavoro proprio del possessore, e che in tutto il processo ulteriore vengano scambiati solo valori eguali con valori eguali, tuttavia, con lo sviluppo progressivo della produzione e dello scambio, arriviamo necessariamente all’attuale modo di produzione capitalistico, alla monopolizzazione dei mezzi di produzione e di sussistenza nelle mani di una sola classe poco numerosa, alla degradazione dell’altra classe, che costituisce l’enorme maggioranza, a classe di proletari pauperizzati, arriviamo al periodico affermarsi di produzione vertiginosa e di crisi commerciale e a tutta l’odierna anarchia della produzione. Tutto il processo viene spiegato da cause puramente economiche senza che neppure una sola volta ci sia stato bisogno della rapina, della violenza, dello Stato, o di qualsiasi interferenza politica. La “proprietà fondata sulla violenza” si dimostra qui semplicemente come una frase da spaccone destinata a coprire la mancanza di intelligenza dello svolgimento reale delle cose>>.
Ancora oggi non è stata capita la dinamica del vecchio capitalismo di matrice inglese, immaginatevi quanto siamo indietro sull’attuale comprensione della formazione sociale capitalistica di matrice americana. Lasciamo perdere Proudhon, lasciamo stare in parte anche Marx (che però sta a Proudhon come un Galilei sta ad un alchimista) e pensiamo finalmente la storia e la scienza sociale dei nostri giorni, così convulsi e faticosi.
Continua a leggere
1. Per comodità (teorica) ho sempre utilizzato la tripartizione della società in tre “sfere” (tre grossi ambiti, mai concretamente separati da nette delimitazioni di confine): quella politica, quella economica (con sottosfere produttiva e finanziaria), quella ideologica, che a volte denomino […]
Continua a leggere
1. Non intendo qui diffondermi troppo sui due tipi di razionalità (e di funzioni); su entrambe sono state scritte infinite pagine e considerazioni. Mi interessa semmai chiarire alcune differenze e distinzioni. Innanzitutto, la metis – l’astuzia, il raggiro, […]
Continua a leggere