SU BREXIT, TRUMP E L’INTERCULTURALISMO
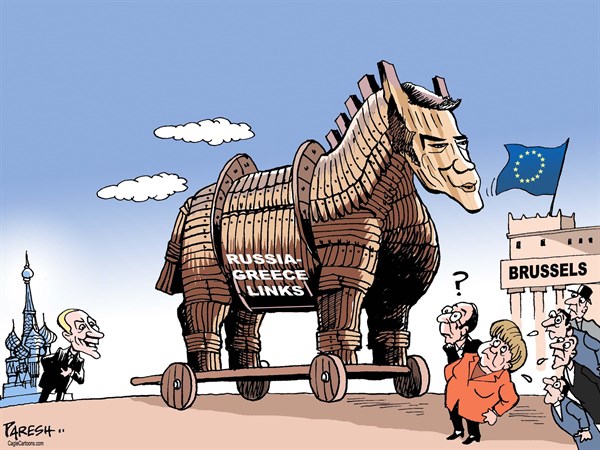
Sul Sole 24 ore (del 19.07.2016) è apparso un articolo di Simon Johnson (1) che vede in Brexit un evento dal quale potrebbero ottenere importanti
<< benefici gli Stati Uniti – l’alleato europeo più importante, nonché il più grande partner commerciale dell’Ue – ma soltanto se alle elezioni per la presidenza a novembre non dovesse vincere Donald Trump, di qui a poco candidato del partito repubblicano>>.
E’ del tutto chiaro in quale posizione politica il noto economista sia situato, al punto che egli ribadisce – in maniera secondo noi “infondata” – la tesi secondo cui Trump sarebbe portatore di un ”isolazionismo” che potrebbe essere altrettanto deleterio per gli Usa come lo è Brexit per il Regno Unito:
<<Le politiche al centro delle elezioni del prossimo presidente degli Stati Uniti sono ovviamente assai diverse da quelle oggetto del dibattito nel Regno Unito per la Brexit. Ma Trump ha una visione simile – in modo quasi impressionante – a quella di Nigel Farage, capo dell’Ukip, il partito indipendentista del Regno Unito, e venerdì entrambi sono apparsi soddisfatti per l’esito del referendum>>.
Secondo Johnson l’elezione di Trump infliggerebbe all’economia statunitense e al mondo intero un grave danno perché porterebbe ad abbracciare una autodistruttiva decisione di erigere muri per isolarsi dalla comunità internazionale. Solo votando per i democratici gli elettori degli Stati Uniti “sceglieranno il benessere” e riproporranno per il loro paese la possibilità di ritornare ad “assumere il ruolo di guida globale”.
In realtà la candidata democratica, Hillary Diane Rodham Clinton, sembra puntare, in base ai temi principali della sua campagna elettorale, su una specie di “credo” che va ormai recitando continuamente: da regole più stringenti per la finanza, a salari minimi più alti, passando per una maggiore uguaglianza tra uomini e donne in materia di retribuzioni. Sempre in ambito economico, il programma elettorale dell’ex senatrice prevede un ampliamento dei crediti d’imposta per le famiglie più povere, un alleggerimento della pressione fiscale per le imprese intenzionate a investire negli Stati Uniti e una netta distinzione fra banche di credito e banche di investimento. Tutto ciò per accreditarsi nella politica “interna” di una posizione più “liberal” di quella obamiana, che non ponga, perciò, al centro solo le questioni climatico-ambientali e quella dei diritti civili ma anche tematiche sociali immediatamente legate al tenore di vita dei ceti medio-bassi negli Usa. In politica estera il discorso si fa “serio” e, quindi, la propaganda lascia il posto a precisi obiettivi. Sui temi “commerciali”, la Clinton non si è ancora espressa sulla questione Trans-Pacific Partnership, tema tanto osteggiato dalla parte più liberal del suo elettorato, ma appare evidente che la sua posizione non si discosterà da quella di Obama mirante ad aumentare a tutti i livelli il controllo politico sulla Ue e l’area europeo / mediterranea. In generale, poi, in politica estera l’ex Segretario di Stato è un’interventista, convinta che non si debbano lasciare vuoti che possano essere colmati dal terrorismo islamico o da fazioni estremiste, anche se – per vari motivi tra i quali la necessità di risparmiare risorse – anche essa potrebbe utilizzare e continuare la “strategia del caos”, portata avanti da Obama, almeno nella prima fase di assestamento dopo la sua eventuale vittoria elettorale. Per quanto riguarda Trump, vediamo che accanto ai soliti temi appaiono anche delle vaghe concessioni alla “destra sociale” a partire dalla “promessa” di una significativa crescita del PIL e dei posti di lavoro per riportare gli Stati Uniti agli antichi fasti economici. Il miliardario newyorkese promette, a questo scopo, una consistente riduzione delle tasse a carico della classe media americana e delle imprese. Le sue idee in materia di politica estera, poi, sono tutt’altro che “isolazioniste”. Da un lato, Trump crede fermamente nella necessità di trovare dei punti di convergenza con Russia e Cina su tematiche di interesse comune, dall’altro minaccia gli alleati NATO di far venir meno l’appoggio americano se questi non dovessero incrementare le spese per la difesa. Inoltre, pur sottolineando la sua contrarietà a mandare truppe all’estero se non in casi eccezionali e di estrema necessità, il candidato repubblicano si dichiara convinto dell’impellenza di sconfiggere l’ISIS. Comunque sul piano “ambientale” e sulle questioni riguardanti l’immigrazione e la cittadinanza, Trump continua a propugnare posizioni “estremiste”. Anche in questo caso, però, viene da pensare che le necessità della propaganda giochino un ruolo fondamentale nella riproposizione di tesi nazionalistiche forti e sostanzialmente “razziste” e di difesa esasperata degli interessi delle lobbies del petrolio. “Law” e “order”, legge e ordine possono venire ottenute solo evitando l’estremizzazione degli antagonismi sociali e magari tenendo in debito conto il grande business imprenditoriale di riconversione ambientale, rispetto al quale ancora una volta gli Usa sono in possesso delle risorse tecnologiche migliori. Per quanto riguarda le prospettive della Gran Bretagna dopo Brexit Johnson scrive:
<< Nell’Ue il Regno Unito spedisce circa la metà delle sue esportazioni, e le prospettive di un accesso completo e continuo a questo mercato sono scarse. Potrà quindi risentirne il commercio di beni e prodotti, ma l’impatto sull’esportazione di servizi, compresi quelli finanziari, sarà di gran lunga più grave. In linea teorica, la Gran Bretagna potrebbe ora negoziare un trattato a tutto campo per avere accesso al mercato Ue, ma quasi certamente ciò esigerebbe di accettare le regole fissate a Bruxelles, proprio quelle contro cui si è scagliato il voto britannico. Di conseguenza, nel Regno Unito la crescita sarà inferiore, e per molto tempo>>.
E, d’altra parte, l’altra “grande perdente” della vittoria dei “secessionisti” appare la Ue poiché senza un sesto circa del suo Pil attuale nei “ranking economici” scenderà da appena sotto il livello degli Stati Uniti – alcuni direbbero sotto e basta – più o meno al livello della Cina (misurato in base agli attuali tassi di cambio). E inoltre, come osserva l’economista angloamericano,
<< una crescita globale più lenta e prezzi petroliferi in ribasso non sono certo buone notizie per Paesi come la Russia di Putin e l’Iran. Infine, la Cina continua a rimanere un’economia nella quale la crescita si basa in gran parte sull’esportazione di manufatti in Paesi più ricchi, e di conseguenza un rallentamento dell’economia nel Regno Unito e nell’Ue non avvantaggerà neppure i cinesi>>. Nelle sue conclusioni il professore del Mit avanza, invece, una tesi che riteniamo assolutamente errata:
<<In termini geopolitici ed economici, gli Stati Uniti sono in teoria coloro che più hanno da guadagnare dalla disintegrazione dell’Ue. Gli Usa divennero una potenza globale mentre gli europei si facevano guerra e i loro imperi andavano incontro al declino>>.
Nonostante sia in atto l’avanzamento di una nuova fase multipolare e di disordine globale la stessa nascita dell’euro e gli avvenimenti del periodo antecedente all’esplosione della crisi globale avevano già accentuato la supremazia Usa nei confronti della Ue e dello “spazio” europeo. E per consolidare la propria egemonia gli Stati Uniti hanno proprio bisogno di questa “Europa unita” che rimarrà chissà per quanto tempo un “nano” politico e un satellite della Nato.
***
Concludo con una breve considerazione sul problema dell’immigrazione. In un recente intervento su questo blog, La Grassa ha scritto:
<< Sono poi vivamente irritato dagli stupidi discorsi intorno alla diversità che arricchisce. Arricchisce (e nemmeno sempre) se gruppi di popolazioni diverse s’incontrano senza tuttavia essere sradicati dal loro territorio, dalla loro cultura e modo di vita e via dicendo. L’incontro di diversità è un conto; la mescolanza confusa e indifferenziata impoverisce culturalmente, crea attriti e conflitti, impoverisce e abbrutisce sotto tutti i punti di vista. Gli Usa da quasi due secoli ricevono migranti di tutti i colori e culture. Si è ben visto proprio in questi giorni come si sono ben integrati neri e bianchi, ecc. E gli Usa reggono perché sono ancora, e già da un secolo o poco meno, la più grande potenza mondiale, quella con più ampie sfere d’influenza. Se dovessero conoscere un periodo di vero declino, i loro guai in tema di convivenza sociale diverrebbero traumatici>>.
I contrasti – che in una fase di crisi sociale ed economica che si presenta come una depressione di lunga durata – tenderanno inevitabilmente a sorgere tra i lavoratori autoctoni e quelli immigrati, porteranno quasi sicuramente all’interno dei gruppi sociali del lavoro dipendente e autonomo, e tra le persone giovani o meno giovani in cerca di occupazione, ad una regressione e involuzione ideologico-culturale molto grave. Si formerà una massa di disoccupati e di occupati a basso livello di reddito, divisa e costituita da piccoli aggregati in forte competizione, con una “coscienza” simile a quella che veniva attribuita al marxiano “Lumpenproletariat”. Ciò favorirà i gruppi dominanti e, ovviamente, in primis, quelli legati alla superpotenza d’oltreoceano e rappresentati, in Italia, dai due maggiori partiti del momento. Queste masse manipolabili e pronte a tutto, pur di ottenere una possibilità di inserimento nello strato sociale dei lavoratori che hanno un posto sufficientemente sicuro e una retribuzione decente saranno utilizzate, sia a livello elettorale sia per alimentare mobilitazioni pilotate “di massa”, allo scopo di confondere le acque e soprattutto con l’intento di influenzare le posizioni e orientare il consenso di quel folto “ceto sociale medio (basso)” sempre più spaventato dalla crisi.
In una recensione di Fiorenza Quercioli ad un libro, del 2002, che si occupava della cosiddetta “educazione interculturale”, con particolare riferimento al sistema scolastico italiano, si trova scritto:
<<In effetti multiculturale e interculturale sono due termini spesso usati come sinonimi, ma in realtà non sono equivalenti, anzi fra i due esiste una differenza tale da connotare due approcci diametralmente opposti verso la questione dell’integrazione degli immigrati e dei loro figli nel paese di approdo. Multiculturale è infatti quella comunità (nazionale, scolastica, sociale) in cui sono presenti più popoli o etnie che tuttavia rimangono separati fra di loro, ognuno nella propria zona fisica e culturale e che raramente entrano in contatto; interculturale definisce invece un contesto relazionale in cui i vari gruppi linguistici e culturali stabiliscono fra di loro un costante rapporto dialettico di arricchimento reciproco fondato sul mutuo rispetto, sull’interesse per ciò che l’altro rappresenta o può rappresentare. A ben guardare, le società multiculturali sottendono il forte etnocentrismo del gruppo dominante, che propugnando l’omologazione al proprio modello, cerca di assimilare le differenze, fino a cancellare o almeno rendere invisibile ogni manifestazione di alterità. In questo caso il contatto fra le varie etnie spesso si risolve in conflitto piuttosto che in dialogo perché in un gruppo emerge il desiderio di non soccombere culturalmente e questo può essere manipolato da leaders carismatici e senza scrupoli, pronti a sfruttare la rabbia e la frustrazione che serpeggiano nella comunità, per scopi tutt’altro che leciti. Al contrario, nelle società interculturali il gruppo dominante è il gruppo accogliente che individua e promuove strategie di incontro fra le culture in modo da creare occasioni positive di conoscenza reciproca e da valorizzare le differenze presenti al suo interno. In questo contesto il contatto fra le varie etnie è costante e produce un sistema di relazioni e di valori che si definisce proprio attraverso il confronto positivo fra le varie realtà culturali>>.
Se prendiamo sul serio questi passi non ci resta che ribadire che mentre il multiculturalismo è un “fatto sociale” e una fonte di conflitti e di criticità sociali e politiche l’ideologia interculturale non è altro che la classica visione utopica, ad uso e consumo delle “anime belle” incapaci di comprendere di essere dei burattini nelle mani degli autentici agenti decisori i quali utilizzeranno le loro fantasie- condite magari da una “buona fede” che ha l’impronta dell’”ottusità saccente” – per preparare il caos necessario a scatenare gli “istinti animali” delle masse.
(1)Simon Johnson è professore di Imprenditorialità alla Sloan School of Management del Mit. Nato nel 1954, Simon Johnson si è laureato all’Università di Manchester e ha ottenuto il Ph.D a Oxford.A cavallo tra il 2007 e il 2008 è stato capo economista del Fondo Monetario Internazionale.
Mauro Tozzato 02.08.2016
